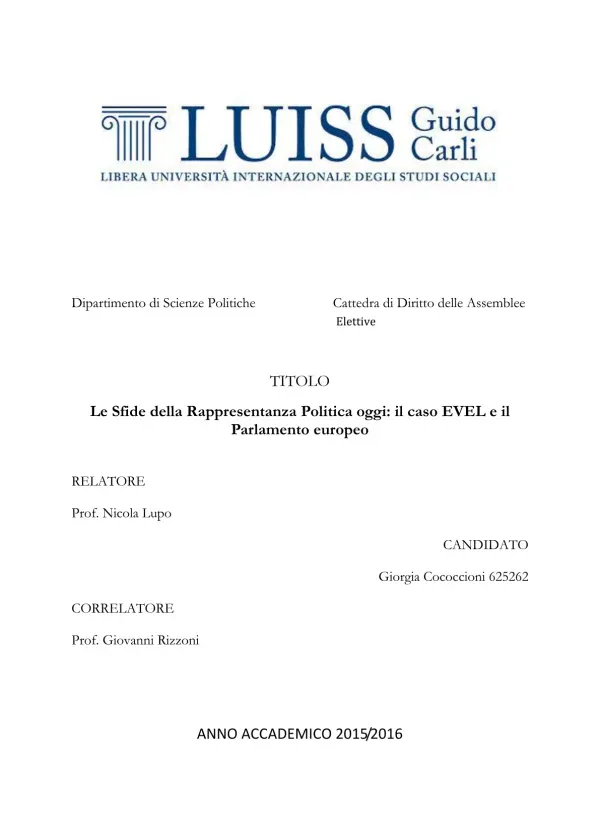
Rappresentanza politica: sfide e casi
Informazioni sul documento
| Autore | Giorgia Cococcioni |
| instructor | Prof. Nicola Lupo |
| Scuola | Dipartimento di Scienze Politiche |
| Specialità | Diritto delle Assemblee Elettive |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.24 MB |
Riassunto
I.La Questione della Rappresentanza nel Regno Unito Devolution e EVEL
Il documento analizza le sfide della rappresentanza politica nel Regno Unito, focalizzandosi sulla devolution in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. L'introduzione di assemblee devolute ha creato squilibri, con l'Inghilterra priva di un'istituzione rappresentativa specifica. La West Lothian Question, ovvero il dibattito sul diritto di voto dei parlamentari delle nazioni devolute su questioni esclusivamente inglesi, ha portato all'introduzione dell'English Votes for English Laws (EVEL). L'EVEL, pur mirando a migliorare la rappresentanza inglese, ha introdotto una complessa procedura di voto con potenziali problemi di stallo istituzionale e incertezza interpretativa da parte dello Speaker. La Barnett Formula, meccanismo di finanziamento devoluto, è un altro punto critico, influenzato dal sistema EVEL e creando disuguaglianze tra le nazioni del Regno Unito. Il referendum sull'indipendenza scozzese del 2014 ha ulteriormente messo in luce la necessità di riforme costituzionali.
1. Devolution nel Regno Unito Squilibri e Mancanza di Rappresentanza Inglese
Il processo di devolution, avviato nel Regno Unito, ha portato alla creazione di assemblee legislative in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, dotate di poteri legislativi primari o secondari. Tuttavia, questo processo ha creato uno squilibrio significativo: l'Inghilterra, a differenza delle altre nazioni costituenti del Regno Unito, non possiede un'istituzione rappresentativa specifica a livello nazionale. La legislazione per l'Inghilterra viene gestita esclusivamente a Westminster, creando una situazione di asimmetria istituzionale. Questo squilibrio è stato ulteriormente accentuato dalla sovra-rappresentazione della Scozia nella House of Commons fino al 2004, quando il numero dei deputati scozzesi è stato ridotto. L'assenza di una rappresentanza dedicata all'Inghilterra, unita alla presenza di assemblee devolute nelle altre nazioni, ha sollevato preoccupazioni sulla partecipazione democratica e sulla responsabilità politica del governo centrale.
2. La West Lothian Question e il dibattito sulla rappresentanza
La cosiddetta "West Lothian Question", sollevata per la prima volta nel 1977, riguarda il diritto di voto dei parlamentari scozzesi, gallesi e nord-irlandesi su questioni che riguardano esclusivamente l'Inghilterra. Il dibattito ha radici storiche, risalendo al XIX secolo con il dibattito sulla Home Rule irlandese. Sebbene storicamente l'influenza dei parlamentari delle nazioni devolute sulle decisioni inglesi sia stata limitata, il governo conservatore, a partire dal 2005, ha inserito nei propri manifesti elettorali la proposta di riformare il diritto di voto a Westminster, impedendo ai parlamentari non inglesi di votare su leggi di esclusiva competenza inglese. Questo riflette una crescente preoccupazione per l'asimmetria nella rappresentanza e la necessità di garantire una maggiore autonomia decisionale per l'Inghilterra.
3. English Votes for English Laws EVEL Meccanismi e Criticità
La riforma EVEL (English Votes for English Laws) mira a risolvere la West Lothian Question, introducendo un meccanismo di veto per i parlamentari inglesi sulle leggi che riguardano esclusivamente l'Inghilterra. La proposta, pur ispirandosi a precedenti meccanismi come i Legislative Grand Committees, presenta criticità. L'introduzione di un nuovo stadio legislativo, con il potere di veto per un "English Grand Committee", potrebbe creare situazioni di stallo istituzionale, rischiando di compromettere la governabilità del Regno Unito. Il sistema della "dual majority", che richiede sia il consenso della Camera dei Comuni che quello della maggioranza dei parlamentari inglesi, introduce ulteriore complessità. Inoltre, la riforma EVEL non affronta adeguatamente il tema della tassazione e dei finanziamenti alle istituzioni devolute attraverso la Barnett Formula, generando potenziali effetti spillovers sui finanziamenti per Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
4. Il Ruolo dello Speaker e le Ambiguità del Devolution Test
L'applicazione pratica dell'EVEL presenta significative ambiguità, in particolare per quanto riguarda il ruolo dello Speaker nella certificazione delle leggi di esclusiva competenza inglese. Lo Speaker, pur non essendo obbligato ad avere competenze legali specifiche sulla devolution, si trova a dover prendere decisioni cruciali, soggette a potenziali pressioni politiche da parte dei partiti. Il report della Public Administration and Constitutional Affairs Committee evidenzia la probabilità di interventi da parte dei partiti sulle decisioni dello Speaker, generando incertezza e potenziali controversie. L'ambiguità del processo di certificazione delle leggi e il ruolo discrezionale dello Speaker mettono in discussione l'effettiva efficacia e la chiarezza del sistema EVEL.
II.La Crisi Democratica nell Unione Europea Rappresentanza e Legittimazione
Il documento esplora il cosiddetto deficit democratico nell'Unione Europea, analizzando la rappresentanza dei cittadini europei nel Parlamento Europeo. La scarsa partecipazione elettorale alle elezioni europee evidenzia una disconnessione tra le istituzioni e l'opinione pubblica. L'ampliamento dei poteri del Parlamento Europeo non ha risolto il problema, con il sistema di co-decisione che genera tensioni tra la formazione di grandi coalizioni politiche e la necessità di raggiungere maggioranze qualificate. La composizione del Parlamento Europeo, basata su una rappresentazione proporzionale degli Stati membri piuttosto che dei cittadini, è stata criticata dal Tribunale Costituzionale Federale tedesco, sollevando questioni relative al principio di uguaglianza del voto. L'integrazione differenziata, come dimostrato dall'accordo di Schengen e dal Fiscal Compact, complica ulteriormente la rappresentanza e la legittimazione democratica.
1. Il Deficit Democratico nell Unione Europea
Il documento evidenzia la percezione di un deficit democratico nell'Unione Europea, particolarmente accentuata dopo la crisi economico-finanziaria del 2008. La crisi ha portato ad un rafforzamento delle istituzioni intergovernative a scapito di quelle comunitarie, concentrando maggiore potere nelle mani degli esecutivi ed escludendo le istituzioni rappresentative dai processi decisionali, soprattutto in materia economica. Questo ha creato un serio problema di legittimazione democratica, aggravato dal fatto che i parlamentari che votano le misure spesso non rappresentano gli Stati membri direttamente interessati dall'applicazione delle stesse. La mancanza di corrispondenza tra chi decide e chi subisce le conseguenze delle decisioni europee mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e alimenta la percezione di una disconnessione democratica.
2. Il Parlamento Europeo Rappresentanza e Partecipazione Cittadina
L'analisi si concentra sul ruolo del Parlamento Europeo nel processo di integrazione europea e nella sua capacità di rappresentare i cittadini. Il documento evidenzia una correlazione inversa tra l'ampliamento dei poteri del Parlamento Europeo e la partecipazione elettorale. Alle elezioni europee del 2014, solo il 42,6% degli elettori ha votato, confermando un trend negativo di partecipazione negli anni. La bassa affluenza alle urne mette in discussione la legittimità democratica del Parlamento Europeo e la sua capacità di rappresentare efficacemente la volontà dei cittadini. La struttura stessa del Parlamento, con un sistema di rappresentanza proporzionale per stati membri piuttosto che per cittadini, è oggetto di critica, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco del 2009 che ne evidenzia la violazione del principio di uguaglianza del voto.
3. Integrazione Differenziata e sfide alla Legittimazione Democratica
Il documento analizza l'impatto dell'integrazione differenziata sulla legittimazione democratica dell'Unione Europea. Accordi come quello di Schengen e il Fiscal Compact, conclusi su base intergovernativa e con la partecipazione volontaria di alcuni Stati membri, dimostrano come la governance europea sia sempre più frammentata. Il Fiscal Compact, in particolare, pur essendo un trattato internazionale, non rientra nelle procedure europee, generando critiche da parte della dottrina che ne sottolinea l'inadeguatezza. Questa scelta di adottare accordi intergovernativi, anziché procedure di cooperazione rafforzata all'interno del quadro comunitario, mina la trasparenza e la partecipazione democratica, creando un'ulteriore frattura tra istituzioni europee e cittadini.
4. Il Messianismo Politico Europeo e la Crisi di Legittimazaione
L'Unione Europea, fin dalle sue origini, ha basato la propria legittimazione sulla promessa di un futuro migliore, un messaggio che ha compensato le debolezze della cosiddetta 'input legitimacy'. Questo 'messianismo politico', particolarmente efficace nelle prime fasi dell'integrazione, ha perso efficacia con il passare del tempo. La crescente complessità della realtà e la difficoltà di realizzare le promesse iniziali hanno contribuito ad una crisi di legittimazione. La mancanza di consenso interno all'Unione, unita alla frammentazione del potere esecutivo e alla complessità della governance economica, rende difficile garantire una rappresentanza e un controllo democratici efficaci. Il documento evidenzia come la natura inclusiva del Parlamento Europeo lo renda inadatto all'adozione di soluzioni asimmetriche per differenziare la sua organizzazione in base all'estensione territoriale delle decisioni.
III.Modelli di Rappresentanza Conflitto tra Principio Democratico e Rappresentanza di Interessi
Il documento confronta i modelli di rappresentanza nel Regno Unito e nell'Unione Europea, evidenziando il conflitto tra il principio democratico e la rappresentanza di interessi specifici (territoriali o settoriali). Mentre il Regno Unito si confronta con il problema di una rappresentanza territoriale sbilanciata, l'Unione Europea si scontra con la sfida di garantire una rappresentanza democratica effettiva a livello sovranazionale. L'analisi approfondisce il ruolo delle seconde Camere (Camera dei Lords nel Regno Unito e Senato in altri contesti) come strumento di bilanciamento dei poteri e di garanzia contro la tirannia della maggioranza. Il documento sottolinea l'importanza di una legittimazione democratica forte per evitare un deficit democratico, sia nel Regno Unito che nell'UE, e suggerisce che affidare la rappresentanza e il controllo ad una singola istituzione è inadeguato, soprattutto nell'UE, data la frammentazione del potere esecutivo.
1. Il Bicameralismo Tra Democrazia e Aristocrazia
Il documento inizia analizzando il bicameralismo, soffermandosi sulla sua origine in Inghilterra, dove la struttura bicamerale del Parlamento risale al tardo medioevo. Inizialmente, le seconde camere avevano un carattere aristocratico ed ereditario, mentre le camere basse rappresentavano le classi emergenti. Il bicameralismo, dunque, nasce come strumento per riconciliare democrazia e aristocrazia, un equilibrio che, seppur parzialmente mantenuto in Inghilterra con la Camera dei Lord, ha subito nel tempo diverse riforme a causa della scarsa legittimazione democratica della Camera Alta. La funzione del Senato, o di una seconda camera in generale, è quella di garantire contro la tirannia della maggioranza, evitando la concentrazione del potere in una sola assemblea eletta a suffragio universale, come sostenuto da John Stuart Mill. Tuttavia, la diversa influenza delle seconde camere nei vari sistemi costituzionali rende difficile una visione unitaria del bicameralismo.
2. Rappresentanza Politica vs. Rappresentanza di Interessi
Il testo evidenzia la distinzione tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi. La rappresentanza politica, basata sul principio di uguaglianza, mira a rappresentare il cittadino come soggetto indistinto, mentre la rappresentanza di interessi, territoriale o settoriale, lo considera membro di uno specifico ente o gruppo. L'Europa continentale ha storicamente privilegiato la rappresentanza politica, rifiutando forme di rappresentanza settoriale o territoriale. Questo principio viene messo in discussione sia nel caso del Regno Unito, con le sue problematiche di devolution e la conseguente West Lothian Question, sia nell'Unione Europea, con il deficit democratico e la difficoltà di rappresentare efficacemente i cittadini a livello sovranazionale. La rappresentanza politica, legata al principio di uguaglianza, entra in conflitto con la necessità di considerare le diverse esigenze territoriali o settoriali.
3. Il Caso Scozzese e l Unione Europea Sovranità e Autonomia
Il documento analizza il caso scozzese, dove il referendum sull'indipendenza del 2014 ha evidenziato una percezione di sovranità popolare su questioni relative allo status della Scozia nel Regno Unito. Westminster, in questo caso, ha consentito il referendum senza imporre condizioni di maggioranza qualificata, a differenza di quanto avviene in Canada con il Quebec. Questa situazione viene paragonata al funzionamento dell'Unione Europea, con Ronan Mccrea che definisce il Regno Unito una 'Mini-UE'. Il confronto tra i due casi evidenzia come in entrambi i contesti il principio di rappresentanza entra in conflitto con quello democratico, in particolare nella camera bassa, dove si esprime il principio democratico. Questo conflitto nasce dalla necessità di bilanciare la rappresentanza politica, intesa come uguaglianza dei cittadini, con la rappresentanza territoriale, che tiene conto delle specificità regionali o nazionali.
