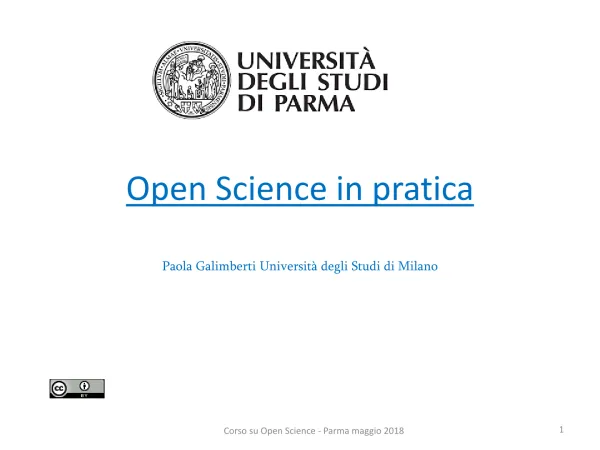
Open Access Italia: Un Movimento dal Basso
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.01 MB |
Riassunto
I.L adozione dell Open Access nelle Università Italiane Una Panoramica
Il documento analizza la situazione dell'Open Access (OA) e dell'Open Science in Italia, evidenziando una diffusione a livello universitario avvenuta principalmente tramite un approccio bottom-up, senza un vero e proprio sostegno da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) o da parte dei Rettori. Nonostante l'adesione massiccia delle università, mancano politiche di sistema coerenti. Il CRUI, nel 2006, ha creato un gruppo di lavoro per la diffusione della cultura dell'accesso aperto, pubblicando raccomandazioni e linee guida, ma senza un'effettiva emanazione da parte del MIUR. L'influenza delle politiche europee sull'Open Access in Italia sembra limitata, con l'ANVUR che non considera l'argomento una priorità. 36 atenei hanno inserito clausole sull'Open Access nei propri statuti, e 24 hanno una policy o un regolamento dedicato. Si evidenzia la necessità di un cambiamento culturale e l'importanza della condivisione degli obiettivi in assenza di obblighi ministeriali.
1. L approccio bottom up e la mancanza di sostegno istituzionale
L'adozione dell'Open Access (OA) nelle università italiane è avvenuta principalmente attraverso un movimento bottom-up, senza un effettivo supporto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) o dei rettori. Nonostante l'adesione massiccia delle università italiane, il documento evidenzia la mancanza di politiche di sistema coerenti per promuovere l'Open Access a livello nazionale. Questa carenza di indirizzo strategico da parte delle istituzioni ha ostacolato una diffusione omogenea e capillare dell'Open Access nel panorama accademico italiano. La situazione si presenta come un'adozione frammentata e disomogenea, dipendente dalla buona volontà e dalla sensibilità di singoli individui all'interno delle varie istituzioni. L'assenza di una guida ministeriale ha portato a una situazione in cui l'implementazione dell'Open Access varia notevolmente da ateneo ad ateneo, rendendo difficile una valutazione complessiva efficace e uniforme.
2. Il ruolo del CRUI e l influenza delle politiche europee
Il documento cita il ruolo del Consiglio Universitario Nazionale (CRUI), che nel 2006 ha costituito un gruppo di lavoro dedicato all'Open Access. Questo gruppo ha prodotto raccomandazioni per la valutazione della ricerca e linee guida per la redazione di policy e regolamenti a livello istituzionale. Tuttavia, queste linee guida non sono state formalmente emanate dal MIUR, limitando la loro efficacia e portata. L'influenza delle politiche europee sull'Open Access in Italia sembra essere minima. Il MIUR non sviluppa politiche specifiche in questo ambito, e l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) non considera l'Open Access una priorità. Questo evidenzia una mancanza di coordinamento e di una strategia nazionale coordinata per l'implementazione delle politiche europee in materia di Open Access.
3. Adozione dell Open Access negli statuti e nelle policy degli atenei
Il documento rileva che, nonostante la mancanza di un'azione coordinata a livello nazionale, un numero significativo di atenei ha intrapreso azioni concrete per promuovere l'Open Access. In particolare, 36 atenei hanno incluso clausole sull'Open Access nei propri statuti, dimostrando una certa sensibilità verso l'argomento. Inoltre, 24 atenei hanno adottato una policy o un regolamento specifico sull'Open Access, mentre 38 hanno una policy per il deposito ad accesso aperto delle tesi di dottorato. Questo dimostra un impegno a livello locale, ma la varietà di approcci e la mancanza di un quadro normativo nazionale sottolineano la necessità di un maggiore coordinamento e di una strategia più uniforme. Il documento sottolinea che l'implementazione dell'Open Access richiede un cambiamento culturale che non avviene rapidamente, e che in assenza di obblighi ministeriali è fondamentale puntare sulla condivisione degli obiettivi.
II.Il ruolo di IRIS e la gestione dei dati di ricerca
Dal 2014, tutte le università italiane utilizzano IRIS, un Current Research Information System (CRIS) basato su DSpace, per la gestione e la diffusione dei dati di ricerca. IRIS ha portato a un cambio di mentalità, rendendo i metadati e, potenzialmente, i full-text delle pubblicazioni accessibili a tutti. Questo ha evidenziato la necessità di una particolare attenzione alla qualità, attendibilità e consistenza dei metadati. L'adozione di IRIS ha però portato alla luce una situazione disomogenea tra gli atenei, con livelli di utilizzo variabili a seconda della buona volontà e della sensibilità dei singoli. La qualità dei dati è fondamentale, specialmente considerando il loro utilizzo per il monitoraggio e la valutazione della ricerca. La certificazione dei dati, la loro completezza e correttezza, diventano quindi aspetti cruciali, richiedendo investimenti in risorse e formazione.
1. Introduzione a IRIS e il suo impatto
Dal 2014, tutte le università italiane hanno adottato IRIS, un Current Research Information System (CRIS) basato su DSpace. Questo sistema rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai precedenti sistemi chiusi, permettendo la gestione e la diffusione dei dati relativi all'attività di ricerca di ciascuna istituzione. L'adozione di IRIS ha comportato un cambio di mentalità, rendendo i metadati della ricerca pubblicamente visibili. Questa maggiore trasparenza ha però richiesto una maggiore attenzione alla qualità, all'attendibilità, alla coerenza e alla consistenza dei metadati stessi. La possibilità di rendere disponibili anche i full-text delle pubblicazioni rappresenta un passo importante verso l'Open Access, ma richiede una gestione accurata dei dati.
2. Gestione e controllo dei dati in IRIS
L'adozione di IRIS ha evidenziato la necessità di un trattamento uniforme dei dati, di un sistema di controllo rigoroso e l'importanza di personale esperto per questa attività. La qualità dei dati è fondamentale, in quanto IRIS diventa la fonte principale per il monitoraggio e la valutazione della ricerca. Errori nei dati portano a conclusioni inaffidabili. Dato che gli utenti di IRIS non sono necessariamente esperti di metadati bibliografici, il documento sottolinea l'importanza di un processo di verifica e correzione affidato a personale qualificato. L'esempio di Parma e Milano viene menzionato in relazione all'indicizzazione, suggerendo una disparità nell'utilizzo e nella cura dei dati tra diverse istituzioni.
3. Analisi della situazione dopo quattro anni e necessità di assicurazione qualità
Dopo quattro anni dall'adozione di IRIS, il documento evidenzia una situazione disomogenea tra gli atenei. Il livello di utilizzo e di efficacia di IRIS varia notevolmente, non essendo frutto di strategie consapevoli e condivise, ma dipendente dalla buona volontà e dalla sensibilità dei singoli operatori. Gli strumenti sono presenti, ma non vengono utilizzati al meglio. La visibilità della ricerca è garantita solo per le istituzioni che hanno curato l'indicizzazione dei propri dati. Per migliorare questa situazione, il documento propone un sistema di assicurazione della qualità, che include la definizione di policy chiare (policy dell'archivio, policy Open Access, policy RDM), la certificazione dei dati e la formazione degli operatori e degli utenti. La certificazione dei dati, se diventa un elemento strategico, richiede investimenti in risorse e formazione.
4. Formazione e sistemi per l assicurazione della qualità
Il documento sottolinea l'importanza della formazione come elemento chiave per garantire la qualità dei dati e l'efficacia di IRIS. La formazione dovrebbe coprire aspetti come la validazione dei metadati, il monitoraggio degli inserimenti e dei full-text, il diritto d'autore e la gestione dei diritti sulle pubblicazioni scientifiche. Si suggerisce la creazione di tutorial, linee guida, video, un helpdesk e una pagina web dedicata all'Open Science sul portale di ogni ateneo. La formazione è necessaria sia per gli operatori che per gli utenti del sistema, per garantire un utilizzo corretto ed efficace di IRIS e per promuovere una cultura della qualità dei dati nella ricerca.
III.Gestione dei Dati di Ricerca RDM e Policy
Il documento sottolinea l'importanza della Research Data Management (RDM), evidenziando la necessità di tracciare l'intero ciclo di vita dei dati e di definire una policy RDM che tenga conto di chi produce i dati, quali tipi di dati vengono prodotti e il livello di apertura e condivisione desiderato. Vengono menzionati modelli di policy come quelli di IOSSG e UNIMI. Si sottolinea che una policy da sola non basta: è necessario uno strumento per gestire il ciclo di vita dei dati e linee guida operative per i ricercatori. L'intero processo richiede una costante osservazione e confronto con gli altri paesi europei.
1. L importanza della Research Data Management RDM
La sezione sottolinea la crescente importanza della Research Data Management (RDM) nel contesto della ricerca scientifica. La riproducibilità delle ricerche, garantita teoricamente per sempre, richiede una gestione accurata dei dati nel tempo. Il documento evidenzia la necessità di definire dove e come i dati vengono conservati, affrontando questioni relative alla titolarità dei dati e al livello di apertura e condivisione desiderato. Gli enti di finanziamento europeo, infatti, richiedono la definizione di un Data Management Plan (DMP) per ogni progetto, sottolineando l'importanza di una pianificazione strategica della gestione dei dati fin dalla fase di progettazione della ricerca. La tracciabilità completa del ciclo di vita dei dati (chi, cosa, quando) è un aspetto fondamentale per garantire la trasparenza e la riproducibilità dei risultati.
2. Definizione e implementazione di una policy RDM
Il documento si concentra sulla definizione di una policy RDM, suggerendo l'utilizzo di interviste e questionari per raccogliere informazioni su chi produce i dati, quali e quanti dati vengono prodotti. Viene fornita una definizione dei research data come record fattuali (dati numerici, simboli, testi, immagini o suoni) utilizzati come fonti primarie della ricerca scientifica, necessari per convalidare i risultati (definizione UNIMI). Il gruppo di lavoro incaricato della stesura della policy deve rappresentare tutte le aree disciplinari per una definizione completa e inclusiva di cosa costituisce i research data. Modelli di policy come quelli di IOSSG e UNIMI vengono menzionati come esempi di riferimento.
3. Oltre la policy strumenti e linee guida operative
Il documento evidenzia che una semplice policy RDM non è sufficiente. È necessario individuare strumenti specifici in grado di gestire il ciclo di vita dei dati, dalla creazione alla conservazione. Inoltre, è fondamentale sviluppare linee guida operative per i ricercatori, fornendo istruzioni chiare su come gestire i dati in diverse situazioni. Questo aspetto pratico è altrettanto importante della policy stessa, per garantire che le linee guida siano effettivamente seguite e applicate dai ricercatori. Infine, si sottolinea l'importanza di un'osservazione costante e di un confronto continuo con le esperienze di altri paesi, in particolare quelli europei, per un continuo miglioramento e adattamento delle policy e delle pratiche RDM.
IV.Formazione e Assicurazione della Qualità
Per garantire l'efficacia dell'Open Access e della RDM, il documento evidenzia la necessità di formazione per gli operatori e gli utenti di IRIS, coprendo argomenti come i metadati e la loro validazione, il diritto d'autore, la gestione dei diritti sulle pubblicazioni scientifiche, e l'utilizzo del sistema. Si suggerisce la creazione di tutorial, linee guida, video, un helpdesk e una pagina web dedicata all'Open Science sul portale di ogni ateneo. La formazione deve anche comprendere gli aspetti della valutazione interna ed esterna, dove i dati vengono utilizzati.
1. La necessità di un sistema di assicurazione della qualità
Il documento evidenzia la necessità di implementare un robusto sistema di assicurazione della qualità per garantire l'efficacia dell'Open Access e della gestione dei dati di ricerca. Questo sistema deve affrontare diverse sfaccettature, dalla definizione di policy chiare alla formazione degli operatori e degli utenti. La definizione di policy specifiche per l'archivio (chi, cosa, quando), per le tipologie di pubblicazione accettate (inclusi metadati), per l'Open Access (dati, pubblicazioni, tesi) e per la Research Data Management (RDM) è fondamentale per stabilire un quadro normativo chiaro e coerente. La certificazione dei dati è un altro aspetto cruciale, soprattutto se i repository diventano strumenti per la valutazione interna ed esterna della ricerca. La completezza e la correttezza delle informazioni sono essenziali per garantire l'affidabilità dei dati.
2. Certificazione dei dati e linee guida
Se la certificazione dei dati diventa un elemento strategico per la valutazione della ricerca, gli atenei devono investire in risorse e formazione. Linee guida condivise sono necessarie per affrontare le diverse criticità e stabilire regole valide per tutti. La formazione, sia attraverso corsi specifici che percorsi di autoformazione, dovrebbe coprire i processi di valutazione interni ed esterni, il diritto d'autore e la gestione dei diritti sulle pubblicazioni scientifiche. Questa formazione è essenziale per garantire che i dati siano gestiti correttamente e che il processo di certificazione sia affidabile e trasparente.
3. Formazione degli operatori e degli utenti
Il documento sottolinea l'importanza della formazione sia per gli operatori che per gli utenti del sistema. Per gli operatori, la formazione dovrebbe includere la validazione dei metadati, il monitoraggio periodico degli inserimenti e dei full-text, e la creazione di tutorial e presentazioni sulla policy di ateneo. Inoltre, è importante fornire presentazioni sull'Open Science e su come applicarla a livello locale. Un helpdesk dedicato può fornire supporto tecnico agli operatori. Per gli utenti, invece, è fondamentale fornire tutorial, linee guida e video sull'utilizzo del sistema, semplificando l'inserimento e la gestione dei dati. Questo approccio multi-livello alla formazione è essenziale per massimizzare l'utilizzo efficace e responsabile dei sistemi di gestione dei dati.
