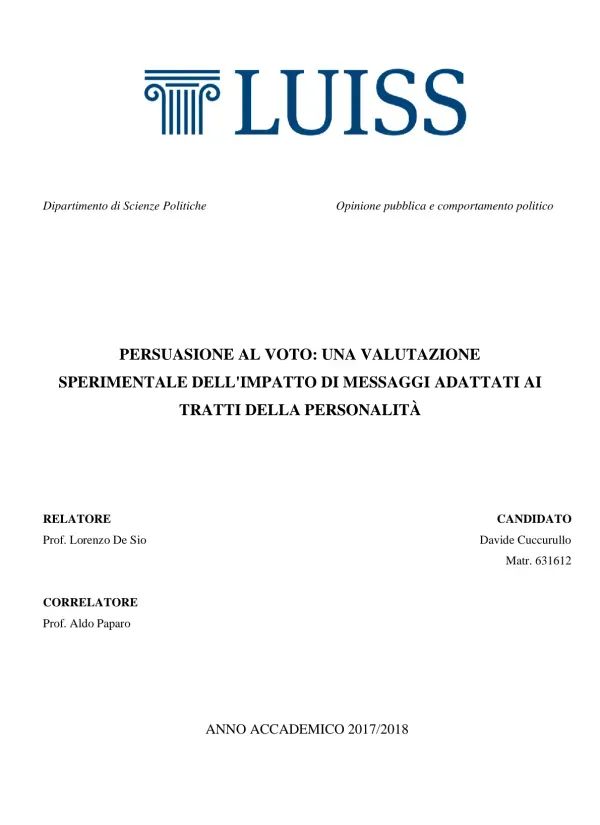
Persuasione politica: impatto dei messaggi personalizzati
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 3.38 MB |
Riassunto
I.Modelli di Comportamento Elettorale Teorie classiche e il ruolo della Personalità
Il documento analizza diversi modelli che cercano di spiegare il comportamento elettorale. Si parte dalle teorie sociologiche (Scuola di Columbia, The People's Choice), che enfatizzano l'influenza dei gruppi sociali e dello status socio-economico. Viene poi esaminata l'identificazione di partito (PID) e la sua capacità di filtrare l'informazione, sebbene questo concetto presenti limiti nelle democrazie europee multipartitiche, dove l'auto-collocazione ideologica (asse sinistra-destra) assume maggiore rilevanza. Infine, si considera la Teoria della scelta razionale e il teorema dell'elettore mediano di Downs, che, sebbene influente, presenta criticità e non spiega completamente il comportamento elettorale.
1. Teorie Sociologiche e lo Studio del Comportamento Elettorale
Il documento introduce le teorie sociologiche come punto di partenza per comprendere il comportamento elettorale, citando lo studio pionieristico "The People’s Choice" (Lazarsfeld, Berelson, e Gaudet, 1944) e la Scuola di Columbia. Lazarsfeld, inizialmente coinvolto nelle ricerche di mercato, ha poi spostato la sua attenzione sull'analisi dei comportamenti di voto e sugli effetti dell'esposizione dei media. Lo studio del 1940 sulle elezioni presidenziali statunitensi (Roosevelt vs. Willkie), con un panel di 600 persone nell'Ohio, ha rivelato l'influenza decisiva dei gruppi sociali di appartenenza, dello status socio-economico, della religione e dell'area di residenza, contraddicendo l'ipotesi iniziale di un voto individuale basato su personalità ed esposizione alla campagna. Questo evidenzia l'importanza del contesto sociale nella formazione delle scelte elettorali, un aspetto centrale nell'approccio sociologico allo studio del voto.
2. L Identificazione di Partito PID e i suoi Limiti
Il concetto di Identificazione di Partito (PID), definito come un legame emotivo duraturo con un partito, viene analizzato come filtro percettivo che influenza l'esposizione, l'accettazione e la conservazione delle informazioni politiche. La PID causa effetti di esposizione selettiva (selective exposure), accettazione selettiva (selective acceptance) e conservazione selettiva (selective retention). Tuttavia, il documento evidenzia la limitata applicabilità della PID alle democrazie europee multipartitiche, dove l'identificazione multipla è frequente. In questi contesti, l'auto-collocazione ideologica sull'asse sinistra-destra diventa uno strumento più efficace per comprendere l'orientamento politico, in quanto capace di adattarsi a nuovi conflitti e contesti. L'indebolimento del legame tra individui e partiti, teorizzato da Dalton con il concetto di partisan dealignment, viene menzionato, ma anche contestato da studi successivi che ne evidenziano l'irrilevanza quantitativa.
3. Il Voto di Scambio e la Teoria della Public Choice
Il documento descrive il voto di scambio, un tipo di voto condizionato da una transazione tra elettore e politico, tipico di contesti di marginalità sociale. Questo tipo di voto è caratterizzato da specificità, discontinuità temporale e dipendenza dalla controprestazione. Si distingue tra voto clientelare (sottoproletariato) e voto parentelare (gruppi piccolo-borghesi), con differenze nel tipo di relazione e durata nel tempo. L'analisi si sposta poi sulla teoria della public choice, che interpreta il comportamento politico attraverso la razionalità degli attori. Il teorema dell'elettore mediano di Downs (1957), basato sulla massimizzazione dell'utilità e sulla volontà dei partiti di vincere le elezioni, viene presentato come pietra miliare della public choice, aprendo la strada ai modelli spaziali in politica. Tuttavia, il documento sottolinea le critiche mosse al modello di Downs, evidenziando come la sua capacità esplicativa del comportamento elettorale sia limitata, in quanto presuppone una informazione perfetta da parte degli elettori, condizione irrealistica nella pratica.
4. Il Ruolo della Personalità nella Teoria del Comportamento Elettorale
Il paragrafo introduce la personalità come variabile del comportamento politico, definendola come la combinazione di caratteristiche che formano il modo di pensare, percepire e comportarsi di un individuo. Si sottolinea la distinzione tra personalità, emozioni, umore e valori. La ricerca sulla personalità autoritaria ("The Authoritarian Personality", Adorno et al., 1950) e la Scala F vengono menzionate come esempi di approcci precoci, seguite dall'analisi dei quattro tratti della personalità (energia, competenza, empatia, onestà) usati dagli elettori per valutare i leader politici. L’analisi evidenzia che mentre energia e competenza ricevono valutazioni trasversali, empatia e onestà sono maggiormente influenzate dalla vicinanza partitica, dimostrando la complessa interazione tra personalità e identificazione politica. La crescente diffusione del microtargeting nelle campagne elettorali, già presente nella campagna Kennedy, e l'importanza dei database elettorali (Demzilla/Datamart, Voter Vault, Aristotle) sono descritti come elementi contestualizzanti.
II.La Personalità come Fattore Determinante nella Scelta di Voto
Il documento esplora il ruolo della personalità, misurata attraverso il modello dei Big Five (OCEAN: Coscienziosità, Estroversione, Amicalità, Nevroticismo, Apertura Mentale), nel predire la scelta di voto. Si fa riferimento a studi che hanno dimostrato la correlazione tra specifici tratti della personalità e le preferenze politiche, ad esempio, l'Apertura Mentale e il voto per partiti liberali. La ricerca analizza come la profilazione psicometrica, basata sui Big Five, può essere utilizzata per il microtargeting politico, personalizzando i messaggi elettorali.
1. Il Modello Big Five OCEAN e la sua Applicazione allo Studio del Comportamento Elettorale
Il documento introduce il modello Big Five della personalità (OCEAN: Coscienziosità, Estroversione, Amicalità, Nevroticismo, Apertura Mentale) come framework per comprendere l'influenza della personalità sulle scelte di voto. Si evidenzia come il modello, comunemente chiamato anche "Big Five", sia utilizzato per analizzare le diverse sfumature di risposta degli elettori a messaggi politici. L'esempio di Cambridge Analytica, che utilizzava il modello per personalizzare i messaggi in base ai tratti di personalità degli elettori, viene citato per illustrare l'applicazione pratica del Big Five nell'ambito del marketing politico. In particolare, viene fatto l'esempio del dibattito sul controllo delle armi: elettori più coscienziosi ricevevano messaggi razionali basati sulla legittima difesa, mentre elettori meno aperti ricevevano messaggi conservatori basati sulla tradizione. Questo dimostra come la comprensione della personalità possa aiutare a rendere più efficace la comunicazione politica.
2. Definizione di Personalità e Distinzione da Concetti Simili
Il testo procede con una definizione di personalità, distinguendola da concetti correlati ma distinti come emozioni (sentimenti intensi), umore (sentimenti meno intensi) e valori (criteri per azioni e valutazioni). La personalità viene definita come una combinazione di caratteristiche e qualità che formano il modo di pensare, percepire e comportarsi di un individuo in diversi contesti (Cantador et al., 2013). Questa distinzione è fondamentale per una corretta applicazione del modello Big Five nello studio del comportamento politico, evitando confusioni che potrebbero compromettere la validità delle analisi. La comprensione di questi concetti distinti è necessaria per una analisi accurata dei dati e per evitare errori interpretativi quando si studiano le correlazioni tra la personalità e le preferenze politiche.
3. Studi Precedenti sull Influenza della Personalità e la Percezione dei Leader
Il documento cita studi precedenti che hanno investigato il ruolo della personalità nel comportamento politico. Si fa riferimento a "The Authoritarian Personality" (Adorno et al., 1950), che ha esplorato la predisposizione al pensiero autoritario in relazione ad esperienze di socializzazione e conflitti irrisolti, introducendo la Scala F per la misurazione. Successivamente, il testo menziona l'analisi di quattro tratti di personalità – energia, competenza, empatia e onestà – utilizzati dagli elettori per valutare i leader politici (Funk, 1999; Kinder, 1986). Si evidenzia che, mentre energia e competenza sono valutate in modo trasversale, empatia e onestà sono influenzate dalla vicinanza partitica, suggerendo una maggiore soggettività nella valutazione di questi ultimi due aspetti. Questi studi precedenti forniscono un contesto importante per la comprensione dell'influenza della personalità sulle preferenze politiche, preparando il terreno per l'analisi del modello Big Five.
4. Il Microtargeting e l Utilizzo dei Database Elettorali
Il testo introduce il microtargeting come tecnica di comunicazione politica che utilizza i database elettorali per personalizzare i messaggi in base alle caratteristiche degli elettori. Si sottolinea la crescente diffusione di questa tecnica, facilitata dall'avvento di internet e dei telefoni cellulari, che aumentano la quantità e la facilità di raccolta delle informazioni. Si cita l'utilizzo di database centralizzati negli Stati Uniti (Demzilla/Datamart, Voter Vault) e il mercato dei dati elettorali, con Aristotle come principale venditore privato di informazioni su 157 milioni di statunitensi. Si sottolinea anche la crescente specializzazione delle società di consulenza politica nella costruzione di database in-house. Questo contesto tecnologico e commerciale fornisce il quadro per comprendere come il microtargeting, combinato con la profilazione psicometrica basata sui tratti di personalità, possa influenzare il comportamento elettorale.
III. Cambridge Analytica Microtargeting Psicometrico e lo Scandalo Facebook
Il caso di Cambridge Analytica viene utilizzato come esempio di microtargeting psicometrico. La società, finanziata dal miliardario Robert Mercer e guidata da Alexander Nix, ha lavorato a oltre 200 campagne elettorali, tra cui quella di Donald Trump. Lo scandalo coinvolge la raccolta illegittima di dati di circa 87 milioni di utenti Facebook tramite l'applicazione creata dal ricercatore Aleksander Kogan. Il documento mette in luce le tecniche di profilazione psicometrica utilizzate da Cambridge Analytica per influenzare il comportamento elettorale, sollevando questioni etiche e legali riguardo alla privacy e al microtargeting politico.
1. Cambridge Analytica Profilo e Attività
Il testo introduce Cambridge Analytica, nata nel 2013 come branca di SCL Group, come società di consulenza politica finanziata, tra gli altri, dal miliardario Robert Mercer, noto sostenitore delle campagne conservatrici. Alexander Nix è stato nominato CEO e Steve Bannon, all'epoca direttore di Breitbart News, vicepresidente. Tra il 2013 e il 2018, Cambridge Analytica ha lavorato a oltre 200 campagne elettorali in tutto il mondo. Il suo coinvolgimento nelle campagne di Ted Cruz e Ben Carson alle primarie repubblicane del 2016 è menzionato, con testimonianze contrastanti sulla sua efficacia. La società ha poi lavorato alla campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016, sebbene il suo ruolo sia stato successivamente ridimensionato da diverse fonti, come il New York Times, che ne descrive un coinvolgimento limitato a spot televisivi, fundraising, targeting pubblicitario online e sondaggi negli swing states. Queste informazioni forniscono un contesto sulla storia e le attività di Cambridge Analytica, evidenziando la sua presenza nel panorama della consulenza politica e il suo controverso ruolo nelle campagne elettorali.
2. Lo Scandalo Facebook e la Raccolta Illecita di Dati
La sezione descrive il ruolo di Cambridge Analytica nello scandalo Facebook del 2018. Il testo spiega come Aleksander Kogan, ricercatore dell'Università di Cambridge, abbia raccolto dati di circa 87 milioni di utenti Facebook tramite un'applicazione, violando le norme sulla condivisione di dati con terze parti. Michal Kosinski, co-ideatore del modello di profilazione psicometrica OCEAN, rifiutò di collaborare con Kogan a causa della mancanza di trasparenza sull'utilizzo dei dati. Cambridge Analytica ottenne accesso a questo database di dati personali, inclusi i "mi piace" di Facebook, che furono utilizzati per la profilazione psicometrica degli utenti. Facebook, dopo aver scoperto il passaggio illecito dei dati, intimiò a Cambridge Analytica di cancellarli, ma non intraprese azioni decise per recuperarli fino alla pubblicazione delle interviste all'ex dipendente di Cambridge Analytica, Christopher Wylie, nel marzo 2018. L'accaduto viene descritto come più uno scandalo Facebook che di Cambridge Analytica, vista la passività del social network nel risolvere la questione. L'evento mette in luce i rischi connessi alla raccolta e all'utilizzo non autorizzato dei dati personali degli utenti dei social media nel contesto del marketing politico.
3. Microtargeting Psicometrico Efficacia e Criticità
Il paragrafo affronta la questione dell'efficacia del microtargeting psicometrico, utilizzato da Cambridge Analytica. Si interroga sulla possibilità di persuadere gli elettori attraverso messaggi che sfruttano i loro tratti di personalità. Viene menzionato un esperimento condotto per misurare l'effetto persuasivo di messaggi adattati a specifici tratti di personalità, utilizzando la variazione della propensione al voto tra un primo e un secondo questionario. Si discute, inoltre, delle critiche al microtargeting politico, evidenziando potenziali effetti negativi come l'effetto divisione (candidati che assumono posizioni estreme), l'effetto discriminazione (campagne concentrate solo su elettori facilmente persuasibili), l'effetto astensione (elettori ignorati meno propensi a votare) e l'effetto raffreddamento (cittadini scoraggiati dalla partecipazione politica per proteggere la propria privacy). Questi punti sollevano importanti considerazioni etiche e politiche sull'utilizzo di tecniche di profilazione psicometrica nel contesto delle campagne elettorali.
IV.Ricerca Empirica Personalità e Propensione al Voto in Italia
La ricerca presenta un esperimento condotto in Italia per valutare l'influenza dei Big Five sulla propensione al voto. Utilizzando questionari per misurare i tratti di personalità e la propensione al voto per diversi partiti (PD, M5S, Lega, FI, FdI, LeU, Più Europa), si sono evidenziate correlazioni significative tra l'Apertura Mentale e la propensione al voto per partiti favorevoli all'integrazione europea, e altre relazioni tra altri tratti di personalità e l'orientamento politico. I risultati suggeriscono che la personalità è una variabile rilevante nei modelli di comportamento elettorale italiano.
1. Obiettivi della Ricerca Empirica e Metodologia
La ricerca empirica si propone di analizzare la relazione tra i tratti di personalità, misurati tramite il modello Big Five, e la propensione al voto in Italia. Si concentra su due quesiti principali: 1) l'esistenza di legami tra i tratti di personalità degli elettori e la loro scelta di voto; 2) il tipo di relazione che intercorre tra queste due variabili. Per misurare la propensione al voto, viene utilizzato un indice che considera le opinioni dell'intervistato nei confronti di tutti i partiti, al fine di individuare eventuali sovrapposizioni tra le preferenze. Per la misurazione dei tratti di personalità, viene impiegato un questionario basato sul modello del Big Five. La ricerca utilizza dati relativi alle elezioni politiche italiane per la Camera dei Deputati del 4 marzo 2018, considerando i partiti che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberi e Uguali e Più Europa. L'utilizzo del modello Big Five permette un'analisi più approfondita del ruolo della personalità nel comportamento elettorale rispetto agli studi precedenti, che spesso hanno adottato un approccio più frammentario.
2. Strumenti di Misurazione Questionari e Indice di Propensione al Voto PTV
La ricerca utilizza un questionario strutturato in tre sezioni principali. La seconda sezione, composta da dieci domande, è dedicata alla misurazione dei tratti di personalità secondo il modello Big Five. La terza sezione mira a determinare la posizione politica e la propensione al voto per diversi partiti. Agli intervistati viene richiesta l'auto-collocazione sull'asse sinistra-destra e la propensione al voto per ciascun partito considerato, utilizzando una scala da 0 a 10 (0 = per niente probabile, 10 = molto probabile). La formulazione della domanda sulla propensione al voto è studiata per evitare vincoli del voto reale, permettendo agli intervistati di esprimere liberamente le loro preferenze anche per più partiti. Questo approccio metodologico si differenzia da studi precedenti che si limitavano ad analizzare il voto effettivamente espresso, permettendo una maggiore comprensione delle preferenze latenti degli elettori. La combinazione di questi strumenti di misura consente una valutazione più completa della relazione tra personalità e comportamento elettorale.
3. Analisi dei Dati e Risultati Principali
L'analisi dei dati evidenzia correlazioni significative tra la propensione al voto (prima del test, PTV 1) e i tratti di personalità. In particolare, l'apertura mentale mostra relazioni significative con la propensione al voto per tutti i partiti, in linea con le ipotesi iniziali. Più Europa, considerato il partito più aperto all'integrazione europea, presenta una correlazione positiva con l'apertura mentale (𝑟 = 0.21). Al contrario, Lega e Fratelli d'Italia, partiti contrari all'integrazione europea, mostrano una correlazione negativa (𝑟 = −0.19 e 𝑟 = −0.20 rispettivamente). Forza Italia e Movimento Cinque Stelle presentano correlazioni negative simili, riflettendo la loro vicinanza ideologica. Le correlazioni tra apertura mentale e propensione al voto per Partito Democratico e Liberi e Uguali sono positive ma meno significative. L'analisi indica quindi che l'Apertura Mentale influenza significativamente la propensione al voto, con una maggiore propensione verso partiti che condividono una visione più aperta e inclusiva. I risultati per gli altri tratti della personalità sono meno netti.
4. Conclusioni e Implicazioni
L'analisi dei risultati conferma che i tratti di personalità possono essere considerati una variabile significativa nei modelli di comportamento elettorale. L'apertura mentale, la coscienziosità e l'estroversione spiegano parte della variabilità delle propensioni al voto. In particolare, maggiore apertura mentale corrisponde a una maggiore propensione al voto per i partiti favorevoli all'integrazione europea, mentre maggiore coscienziosità è associata a una maggiore propensione per i partiti di destra. Contrariamente ad alcuni studi precedenti, l'estroversione risulta correlata a una maggiore propensione al voto per i partiti di destra. La ricerca evidenzia quindi il contributo della personalità nella comprensione del comportamento di voto in Italia, confermando l'importanza di includere queste variabili nei modelli più complessi per spiegare le scelte elettorali. I risultati suggeriscono la necessità di ulteriori ricerche per approfondire le relazioni tra specifici tratti di personalità e le preferenze politiche in diversi contesti.
