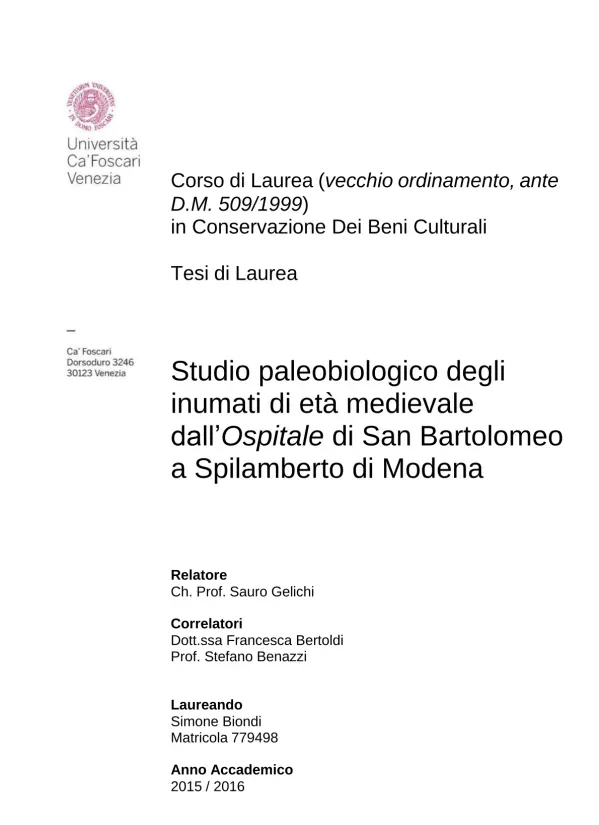
Paleobiologia medievale: Studio a Spilamberto
Informazioni sul documento
| Scuola | Corso di Laurea (vecchio ordinamento, ante D.M. 509/1999) in Conservazione Dei Beni Culturali |
| Specialità | Conservazione Dei Beni Culturali |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Luogo | Modena |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 6.62 MB |
Riassunto
I.Analisi Antropologica dei Resti Umani dell Ospitale di San Bartolomeo a Spilamberto
Questo studio di archeologia medievale si concentra sull'analisi antropologica, demografica e paleopatologica di 54 individui (31 sepolture) rinvenuti durante scavi archeologici preventivi nel 2008 presso l'Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO). Le indagini, condotte dall'equipe del Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università di Venezia Ca’ Foscari, integrano i dati archeologici e sono confrontate con studi su altri siti medievali, come l'Abbazia di Nonantola e il cimitero di San Bartolomeo a Formigine. L'analisi include la determinazione del sesso e la stima dell'età alla morte, oltre allo studio di patologie. La posizione delle tombe, l'orientamento (est-ovest e sud-est/nord-ovest) e la presenza di riduzioni intenzionali e casuali sono aspetti cruciali dell'indagine.
II.Metodi di Analisi e Determinazione del Sesso
Per la determinazione del sesso, sono stati impiegati metodi morfoscopici basati sull'analisi del cranio e del bacino (Ferembach et al., 1979; Bruzek, 2002; Minozzi, Canci, 2015; Acsadi e Nemeskeri, 1970; Sauter e Privat, 1955; Bass, 1987), considerando sia caratteri morfologici che indici metrici. L'analisi dello scheletro post-craniale ha integrato i dati, considerando la robustezza ossea e indicatori di markers of occupational stress (M.O.S.). Per gli infanti e i giovani, la determinazione del sesso è risultata più complessa a causa dello sviluppo incompleto dei caratteri sessuali.
1. Determinazione del sesso negli adulti metodi morfoscopici
La determinazione del sesso negli individui adulti si è basata su un'analisi morfoscopica dettagliata. Sono stati utilizzati i metodi di Ferembach et al. (1979), riproposti da Bruzek (2002) e Minozzi, Canci (2015), che si concentrano sui caratteri morfologici del cranio e del bacino. In aggiunta, sono stati considerati gli indici di sessualizzazione di Acsadi e Nemeskeri (1970), l'indice cotilo-sciatico di Sauter e Privat (1955) e le misure delle ossa lunghe di riferimento proposte da Bass (1987). L'analisi ha considerato la forma della faccia, il profilo delle orbite, l'apertura piriforme del naso, la sporgenza delle arcate sopracciliari e dei mascellari, il profilo del cranio e la morfologia della squama occipitale. È stata sottolineata l'importanza del bacino, per la sua relazione con la gestazione e il parto, come indicatore di sesso femminile. I crani maschili presentavano dimensioni maggiori e tratti più marcati, in particolare nella squama occipitale, spesso con depressioni e processi osteofitici. La robustezza delle ossa, associata a valori osteometrici maggiori, è stata osservata anche nei rami mandibolari. Tuttavia, la variabilità individuale è stata considerata un fattore cruciale nell'interpretazione dei dati, così come il rapporto di robustezza all'interno del gruppo esaminato.
2. Determinazione del sesso Scheletro post craniale e indicatori complementari
Oltre al cranio e al bacino, il grado di robustezza delle ossa e le dimensioni epifisarie dello scheletro post-craniale sono stati utilizzati come parametri distintivi secondari, sebbene con cautela a causa della variabilità individuale e del rapporto di robustezza all'interno del gruppo. Anche nei soggetti femminili, infatti, l'esercizio di stress fisico-muscolare importante e continuato poteva determinare un aumento della robustezza scheletrica. Sono stati quindi valutati indicatori complementari e secondari, tra cui quelli proposti da Minozzi e Canci (2015) e l'indice cotilo-sciatico di Sauter e Privat (1955), applicato in relazione ai range calibrati. Questi indici comprendono le caratteristiche della superficie auricolare, dell'incisura ischiatica, la presenza/assenza dell'arco composto, le caratteristiche del ramo ischio-pubico, la dimensione della faccetta articolare sacro-iliaca, la morfologia della cresta superiore dell'ileo, l'arco ventrale, e la forma delle pelvi maggiori e minori. L'obiettivo era utilizzare questi parametri come conferme supplementari per la determinazione del sesso, integrando le informazioni ricavate dall'analisi del cranio e del bacino.
3. Determinazione del sesso nei resti infantili e giovanili
La determinazione del sesso nei resti infantili e giovanili si è dimostrata spesso limitata o impossibile. La frammentazione dei resti ossei, dovuta al grado di conservazione, e il mancato sviluppo del dimorfismo sessuale, rendono difficile la diagnosi, con una precisione che non supera il 70% nei soggetti adolescenziali. Per questo motivo, nell'analisi delle sepolture infantili maggiori di 14 anni, si è optato per la registrazione dei soli caratteri utili per la stima dell'età, secondo i metodi descritti nel capitolo successivo. La difficoltà nella determinazione del sesso in queste fasce di età è dovuta alla mancanza di caratteri distintivi completamente sviluppati. La conservazione dei resti gioca un ruolo fondamentale, con una frammentazione spesso significativa che impedisce una valutazione accurata. Il dimorfismo sessuale, ovvero le differenze scheletriche tra maschi e femmine, non è ancora pienamente espresso in età infantile e giovanile, rendendo l'identificazione del sesso estremamente complicata.
III.Determinazione dell Età e Patologie
La stima dell'età è stata effettuata utilizzando diversi metodi, tra cui l'analisi dello sviluppo dentario (Ubelaker), la fusione delle suture craniche (Acsadi e Nemeskeri, 1970; Meindl e Lovejoy, 1985), e l'analisi morfologica della faccetta auricolare (Schmitt, modificato da Mulhern e Jones, 2005). Lo studio ha rivelato una significativa presenza di osteoartrosi e un caso di brucellosi. L'analisi dei denti ha evidenziato usura e carie, correlata anche alle abitudini alimentari dei monaci (consumo di cibi duri, come noci). La dieta, attentamente regolamentata dall'ordine benedettino, ha influenzato la salute orale e generale degli individui. La presenza di indicatori di stress fisico (M.O.S.) suggerisce attività lavorative intense per alcuni individui. Un'analisi della mortalità infantile evidenzia la vulnerabilità dei più piccoli a malattie infettive.
IV.Risultati e Conclusioni Aspetti Demografici e Comparazione con Altri Siti
I risultati mostrano una prevalenza di maschi (52%) rispetto alle femmine (14%) nel campione adulto. Le caratteristiche craniche mostrano una certa eterogeneità, suggerendo una diversità di origini dei defunti. La Via Francigena, importante via di pellegrinaggio, ha probabilmente influenzato la composizione della popolazione dell'Ospitale di San Bartolomeo. La longevità e lo stato di salute degli inumati, a eccezione dell'alta incidenza di osteoartrosi, sono notevoli. I dati demografici e paleopatologici di San Bartolomeo mostrano differenze rispetto a siti coevi come Formigine e Nonantola, avvicinandosi di più a Ravenna. L'ospedale, attivo già dal 1162 (notizia confermata da una bolla pontificia del 1191), ha subito ampliamenti strutturali fra la fine del XII e il XIV-XV secolo, aumentando la sua capacità di accoglienza di pellegrini e bisognosi.
