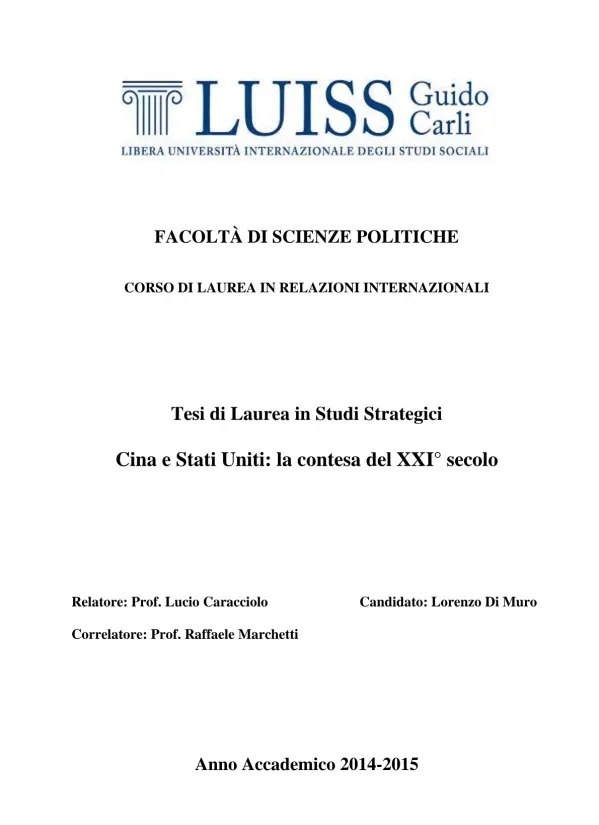
Cina-USA: La Contesa Globale
Informazioni sul documento
| Scuola | Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Relazioni Internazionali |
| Specialità | Studi Strategici |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.83 MB |
Riassunto
I.Il Voltofaccia di Washington e la Relazione Economico Politica con la Cina 1994 2000
Questo periodo è caratterizzato da un progressivo ammorbidimento dell'atteggiamento di Washington nei confronti della RPC, culminato nel 1994 con lo sganciamento della clausola sui diritti umani dal rinnovo dello status MFN (Most Favored Nation). Questo cambiamento, favorito da una forte lobbying di grandi corporation (General Motors, Chrysler, Procter & Gamble, Coca-Cola, Motorola, IBM) e da figure influenti come James Baker e Brent Scowcroft, ha preparato il terreno per il "permanent trade relations bill" del 2000. Tale decisione, se da un lato ha favorito la ripresa economica nel quadro del neoliberismo, dall'altro ha rappresentato una perdita di coerenza, sia internamente che a livello internazionale, con il Congresso che manteneva una posizione pro-Taiwan e imponeva sanzioni alla RPC.
1. L evoluzione dell atteggiamento di Washington verso la Cina
Il testo descrive un cambiamento significativo nell'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica Popolare Cinese (RPC) tra il 1994 e il 2000. Si evidenzia un progressivo ammorbidimento della posizione americana, testimoniato dallo sganciamento, nel maggio del 1994, della clausola sui diritti umani dal rinnovo dello status MFN (Most Favored Nation) per la Cina. Questo evento, presentato come un 'voltafaccia' dell'amministrazione Clinton, anticipava la futura concessione del "permanent trade relations bill", siglato nell'ottobre del 2000. Tale svolta strategica è attribuita a una potente attività di lobbying da parte di grandi aziende americane come General Motors, Chrysler, Procter & Gamble, Coca-Cola, Motorola e IBM, oltre all'appoggio di influenti figure politiche come James Baker e Brent Scowcroft. L'ammorbidimento della posizione americana, volto a privilegiare l'espansione dei rapporti economici a livello regionale e globale, contrasta con l'incertezza della politica estera degli anni '90. Le conseguenze di questa scelta politica sono ambivalenti: da un lato, ha favorito una straordinaria ripresa economica, in linea con un modello neoliberista; dall'altro, ha generato una evidente incoerenza percepita sia dall'elettorato interno che dagli attori internazionali. Questa contraddizione è sottolineata dal contrasto tra la posizione relativamente accomodante della presidenza verso Pechino e la decisa presa di posizione pro-Taiwan del Congresso, che nello stesso periodo ha approvato una serie di sanzioni contro la RPC.
2. Le pressioni economiche e le preoccupazioni del Congresso americano
Sul piano economico, la preoccupazione principale degli Stati Uniti era rappresentata dall'influenza crescente del 'China factor' sul sistema mondiale e le sue ripercussioni sull'economia americana. Questo timore si manifestava in particolare nella preoccupazione per il deficit commerciale record, la presunta manipolazione del tasso di cambio da parte della Cina, la mancata osservanza degli accordi TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e, più in generale, l'impatto di una crescita economica cinese così rapida e basata su una politica estera definita 'mercantilistica'. La US-China Economic and Security Review Commission, nel suo report annuale del 2006, evidenziava queste critiche, sottolineando la mancata applicazione effettiva delle norme e dei regolamenti della World Trade Organization (WTO) da parte di Pechino, nonostante la Cina avesse formalmente riscritto migliaia di leggi e regolamenti durante un periodo di adattamento di cinque anni. Secondo gli analisti americani, la Cina risultava carente nella protezione della proprietà intellettuale, nell'implementazione di un regime di cambio basato sul mercato e nell'adeguamento alle normative WTO sui sussidi alle esportazioni. Malgrado l'annuncio di una riforma del regime di cambio nel luglio 2005, il Congresso americano considerava la sua attuazione insufficiente, definendola una 'modest revaluation' dello Yuan. La valutazione negativa della situazione da parte della Commissione si traduceva in un'accusa di svalutazione artificiale dello Yuan, interpretata come un sussidio alle esportazioni cinesi e una tassa sulle importazioni americane, generando un enorme avanzo di partite correnti per la Cina. Questo avanzo aveva portato a un incremento significativo delle riserve ufficiali della RPC in dollari americani, che dal 1999 al 2006 erano passate da 154 miliardi di dollari a un trilione di dollari, rendendo la Cina il secondo maggiore detentore di dollari dopo il Giappone. Questo fenomeno, sostenuto dall'acquisto di Treasury Bonds da parte della Bank of China, contribuiva a mantenere bassi i tassi di interesse americani, aumentando i deficit gemelli degli Stati Uniti e il costo del debito pubblico. In sostanza, una parte significativa del debito americano, e quindi dello stile di vita americano, era finanziato dal principale concorrente economico degli Stati Uniti.
II.Il Fattore Cina e le Preoccupazioni Economiche degli Stati Uniti 2006
Nel 2006, il rapporto annuale della US-China Economic and Security Review Commission evidenziava le critiche degli USA alla Cina, accusata di non rispettare le norme della WTO, in particolare riguardo alla proprietà intellettuale, al tasso di cambio (RMB/Yuan svalutato del 40%, considerato un sussidio alle esportazioni cinesi), e ai sussidi alle esportazioni. L'enorme avanzo commerciale cinese e il suo ruolo nel finanziare il debito americano (attraverso l'acquisto di Treasury Bonds) alimentavano forti preoccupazioni a Washington riguardo al deficit commerciale e all'influenza economica cinese.
1. Il China Factor e le preoccupazioni americane nel 2006
Nel 2006, la preoccupazione principale degli Stati Uniti riguardo alla Cina ruotava attorno al suo impatto sull'economia globale e su quella americana in particolare. Il testo evidenzia la paura del 'China factor', ovvero l'influenza crescente della Cina sul sistema economico mondiale e le sue conseguenze negative per gli Stati Uniti. Questo timore si concretizzava in diverse aree di preoccupazione: un deficit commerciale americano a livelli record, la sospetta manipolazione del tasso di cambio da parte della Cina (svalutando lo Yuan per favorire le esportazioni), la mancata osservanza degli accordi TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e, in generale, la diffusione dell'influenza economica cinese basata su una politica estera considerata mercantilistica. Questi punti vengono analizzati nel report annuale del 2006 della US-China Economic and Security Review Commission del Congresso. Il documento sottolineava la discrepanza tra l'adesione formale della Cina alle procedure, regole e regolamenti della World Trade Organization (WTO) e la sua effettiva implementazione. La Commissione criticava apertamente Pechino, evidenziando che, nonostante cinque anni di adattamento e la riscrittura di migliaia di leggi e regolamenti, la performance cinese rimaneva insufficiente in diversi settori chiave. La protezione della proprietà intellettuale era ritenuta inadeguata, così come l'adozione di un regime di cambio basato sul libero mercato e l'adeguamento alle normative WTO sui sussidi alle esportazioni. L'enorme avanzo commerciale cinese era considerato un'ulteriore prova di questa ineguale competizione economica.
2. La svalutazione dello Yuan e il finanziamento del debito americano
Un aspetto cruciale delle preoccupazioni economiche americane era la presunta svalutazione dello Yuan (RMB) del 40%, descritta come un 'subsidy for Chinese exports to the United States and a tax on imports from the United States'. Questa svalutazione, secondo il Congresso, costituiva un vantaggio competitivo ingiusto per le esportazioni cinesi, danneggiando le imprese e l'economia americana. L'enorme avanzo delle partite correnti della Cina, conseguenza diretta di questa situazione, ha portato a un accumulo massiccio di riserve ufficiali in dollari americani. Queste riserve, cresciute da 154 miliardi di dollari nel 1999 a un trilione di dollari nel 2006, facevano della Cina il secondo maggiore detentore di dollari al mondo, dopo il Giappone. Questo aspetto è strettamente legato al ruolo della Bank of China nel sostenere l'offerta di Treasury Bonds. L'acquisto massiccio di questi titoli di Stato americani da parte della banca cinese impediva un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, contribuendo a mantenere artificialmente bassi i costi del debito americano. Tuttavia, questa situazione presentava un paradosso significativo: una quota sempre maggiore del debito degli Stati Uniti, e quindi del 'American way of life', era finanziata dal suo principale competitor economico. Questo rapporto di interdipendenza economica, quindi, sollevava gravi preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità economica a lungo termine degli Stati Uniti.
III.La Strategia di Hedging degli Stati Uniti e il Rinforzo delle Alleanze 2005 2006
Di fronte all'ascesa della Cina, gli USA, ribadendo la dottrina Wolfowitz dello preemptive strike, hanno optato per una strategia di hedging, rafforzando le alleanze tradizionali (Giappone, rinnovando il trattato difensivo che includeva lo stretto di Taiwan) e creando nuove partnership strategiche (India, inserita nel Quadrilateral Security Dialogue con Australia e Giappone). Sono stati incrementati gli aiuti economici e l'assistenza militare a paesi come Mongolia, Filippine, Singapore, Vietnam, Tailandia, Taiwan e Indonesia per creare una rete di relazioni bilaterali, soprattutto in ambito militare, nell'area Asia-Pacifico, in risposta all'espansione del potenziale bellico cinese, evidenziato nel Report on RPC Military Power del 2006.
1. La Dottrina Wolfowitz e la Strategia di Hedging
Nel 2006, la crescente preoccupazione per l'ascesa militare della Cina portò gli Stati Uniti ad adottare una strategia di hedging. Questa strategia, in risposta alla dottrina Wolfowitz del "preemptive strike" (gli Stati Uniti non avrebbero aspettato di essere attaccati per agire contro minacce percepite), si concretizzava nel rafforzamento delle alleanze esistenti e nella creazione di nuove partnership strategiche. La Quadriennal Defense Review del 2006 riaffermava questa dottrina aggressiva, evidenziando la necessità di un'azione preventiva contro le minacce percepite. Il testo evidenzia il contesto di crescente timore e perplessità nei confronti del "crocevia strategico" rappresentato dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC). L'obiettivo principale dell'approccio americano era quello di creare una "deep network of strategic bilateral relations", ovvero una rete profonda di relazioni bilaterali strategiche a livello regionale. Questo si traduceva in un'azione mirata a rinsaldare i legami con alleati tradizionali e a stringere nuove alleanze con paesi chiave, con l'obiettivo di contenere l'influenza crescente della Cina.
2. Rinforzo delle alleanze tradizionali e nuove partnership strategiche
Il rafforzamento delle alleanze esistenti è stato un pilastro chiave della strategia di hedging. In primo luogo, si evidenzia il rinnovamento del trattato difensivo tra Stati Uniti e Giappone nel 2005, che per la prima volta includeva esplicitamente lo stretto di Taiwan come area di potenziale stabilizzazione e di interesse comune. Questo rafforzamento del legame con il Giappone rappresentava una risposta diretta all'espansione del potenziale militare cinese, in particolare riguardo alla minaccia percepita per Taiwan. Un'altra importante partnership strategica fu quella siglata con l'India nel 2005, con il "Next Step in Strategic Partnership", che seguiva un pre-accordo del 2003 sulla cooperazione nucleare e la fornitura di tecnologia militare. Questa alleanza si sarebbe poi ulteriormente rafforzata nel 2007 con l'inclusione dell'India nel Quadrilateral Security Dialogue, insieme ad Australia e Giappone. Oltre a queste partnership principali, gli Stati Uniti hanno intensificato i rapporti con altri paesi della regione Asia-Pacifico. La Mongolia ha ricevuto un cospicuo pacchetto di aiuti economici, le Filippine hanno visto raddoppiare l'assistenza militare americana nel 2004, e sono stati rafforzati i legami difensivi (invio di consiglieri militari, cooperazione nell'ammodernamento degli apparati bellici e logistici, esercitazioni congiunte) con Singapore, Vietnam, Tailandia, Taiwan e Indonesia. L'obiettivo era quello di creare una rete di relazioni bilaterali strategiche, prevalentemente di natura militare, per contrastare l'influenza crescente della Cina nella regione.
3. Il passaggio di testimone tra l amministrazione Bush e Obama
Il periodo di transizione tra la presidenza di George W. Bush e quella di Barack Obama è stato caratterizzato da un'analisi più approfondita della posizione da adottare nei confronti della Cina. Tuttavia, il testo sottolinea che il dilemma di fondo non era stato risolto e che una strategia inequivocabile non era stata ancora definita. L'ultima National Security Strategy dell'era Bush presentava il dilemma come una scelta tra la paura e la fiducia, optando per affrontare le sfide presenti invece di lasciarle alle generazioni future. Come conseguenza di questi timori e perplessità, il focus strategico americano si spostava verso la regione dell'Asia-Pacifico, prefigurando il "Rebalancing" dell'amministrazione Obama. Si prospettava la possibilità di un ribilanciamento della macchina bellica americana, con l'assegnazione di almeno la metà delle forze armate alla regione Asia-Pacifico, in risposta all'ascesa della Cina. Questa previsione, sostenuta soprattutto dal Pentagono, dalle lobby industriali e da settori influenti della politica americana, preparava il terreno per un nuovo corso della strategia americana, che sarebbe stato implementato dall'amministrazione Obama dopo un infruttuoso tentativo di approccio concertativo con la Cina. L'intensificazione dei legami militari nella regione avrebbe però inevitabilmente portato a un'aggravamento della "Irritable Border Syndrome" della RPC, secondo l'analisi di Robert Kaplan.
IV.L Amministrazione Obama e il Tentativo di Concertazione 2009 2012
L'amministrazione Obama ha tentato un approccio di concertazione con la Cina, promuovendo un dialogo bilaterale e un maggiore ruolo della Cina nel sistema internazionale con maggiori responsabilità. Tuttavia, la Cina si è dimostrata inflessibile nel proteggere i suoi interessi nazionali (sviluppo economico, sovranità nazionale e integrità territoriale), lasciando spazio a conflitti interpretativi su questioni come Taiwan, Tibet e Xinjiang. La proliferazione nucleare (Corea del Nord e Iran) e la questione economica (compresa la rivalutazione dello Yuan e la richiesta di ribilanciare la domanda globale) sono rimaste punti di contrasto.
1. L approccio concertativo dell amministrazione Obama e le sue difficoltà
L'amministrazione Obama, tra il 2009 e il 2012, ha tentato un approccio di concertazione con la Cina, nel tentativo di definire una nuova tipologia di relazione tra le due maggiori potenze. Obama, primo presidente a visitare la Cina nel primo anno del suo mandato, ha affermato che le relazioni sino-americane avrebbero modellato il XXI secolo e che la Cina avrebbe dovuto assumere un ruolo maggiore, proporzionato alle sue crescenti responsabilità. A novembre dello stesso anno è stato siglato un Joint Communiqué, il primo dopo l'incontro Clinton-Jiang Zemin del 1997, che sottolineava l'importanza del ruolo americano per la pace e la sicurezza nell'Asia-Pacifico e la convergenza di interessi tra USA e RPC. Tuttavia, il documento evidenzia l'inflessibilità della delegazione cinese riguardo all'inclusione di un'espressione chiave: il "respecting each others’ core interests". Questo passaggio sottolineava la determinazione cinese a proteggere i suoi interessi nazionali fondamentali, ovvero lo sviluppo economico, la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, senza compromessi. L'ambiguità su cosa costituisse esattamente questi 'core interests' lasciava spazio a potenziali conflitti interpretativi su questioni come Taiwan, Tibet, Xinjiang e le rivendicazioni marittime nel Mar Cinese Meridionale.
2. Punti di Contatto e Contrasto Economia Proliferazione Nucleare e Questioni Regionali
Il tentativo di concertazione tra Stati Uniti e Cina si è scontrato con diverse difficoltà. La questione economica, seppur gestita in un regime di condominio a causa dell'interdipendenza tra i due paesi, non ha portato a una convergenza strategica di lungo periodo. La proliferazione nucleare, in particolare per quanto riguarda Corea del Nord e Iran, è stata un altro punto di contrasto. Nonostante l'appoggio cinese alle risoluzioni ONU (risoluzione 1874 del 2009 e 1985/1929 dell'anno successivo), ottenuto da Washington anche con minacce, la posizione di Pechino rimaneva ambigua. Questa ambiguità era dettata dall'importanza strategico-economica dei legami con l'Iran, con il quale la Cina continuava a firmare contratti per la fornitura di idrocarburi, e dalla necessità di mantenere la continuità territoriale per espandere la sua influenza dall'Asia orientale al Golfo Persico. Anche la questione della Corea del Nord, nonostante le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha mostrato la stretta dipendenza di Pyongyang da Pechino per gli approvvigionamenti. Infine, l'instabilità in Afghanistan e Pakistan, di interesse sia per gli Stati Uniti che per la Cina (per motivi diversi), non ha visto alcuna convergenza di soluzioni pratiche, dimostrando la complessità e i limiti dell'approccio concertativo.
3. La rivalutazione dello Yuan e le pressioni economiche americane
Un punto di forte tensione tra le due potenze è stata la questione economica, in particolare la rivalutazione dello Yuan. Gli Stati Uniti, sotto la presidenza Obama, premevano per un aggiustamento del sistema di cambio cinese, più in linea con l'andamento dei mercati, per rilanciare le esportazioni americane e creare nuovi posti di lavoro. Questo bisogno di ribilanciare le fonti della domanda globale e la determinazione del tasso di cambio di mercato, che avrebbe invertito una significativa sottovalutazione dello Yuan, era considerato uno strumento chiave per una robusta ripresa economica globale. Nonostante la Cina avesse annunciato una ulteriore rivalutazione dello Yuan a metà 2008 (in aggiunta a quella del 2005), gli Stati Uniti, durante il G20 di Seoul del 2009, chiedevano cambiamenti più rapidi e decisivi. La nuova politica espansiva della Federal Reserve, con un nuovo stimolo di 600 miliardi di dollari attraverso il quantitative easing, era percepita dalla Cina e dagli altri grandi paesi esportatori come una minaccia alle loro politiche commerciali, accentuando le tensioni economiche tra le due superpotenze. Questa situazione di interdipendenza economica, paradossalmente, favoriva più gli interessi cinesi che quelli americani nel breve periodo, a causa della capacità della Cina di difendere i propri interessi nazionali in un sistema internazionale in transizione.
V.Le Contraddittorie Politiche Cinesi e la Transizione Interna 2007 2012
Il XVII Congresso del PCC del 2007 ha sottolineato la necessità di uno sviluppo scientifico più sostenibile e orientato alle persone, in risposta a problemi come la corruzione, l'inquinamento, e le disuguaglianze sociali. Nonostante l'obiettivo di una "società armoniosa", la Cina ha continuato a perseguire i propri interessi a livello internazionale, manifestando contraddizioni durante i vertici del G20 e cercando di aumentare il ruolo dello Yuan nel sistema finanziario globale attraverso accordi di Currency Swap Agreements.
1. Il XVII Congresso del PCC e il concetto di Sviluppo Scientifico
Il periodo 2007-2012 in Cina è caratterizzato da una complessa transizione interna. L'analisi inizia con il XVII Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC) nell'ottobre 2007, che ha visto la riconferma di Hu Jintao alla segreteria del partito. Mentre la riconferma evidenziava la sua capacità di gestire le spinte centrifughe interne al partito, il Congresso ha anche segnato un'evoluzione strategica. Si è assistito a un restringimento del focus rispetto al 6° Plenum del 2006, che aveva enfatizzato la costruzione di una "società armoniosa". Sebbene l'obiettivo di una Harmonious Society rimanga, il XVII Congresso introduce il concetto di "scientific development", un modello di crescita 'people-centered' e razionale, in contrasto con la crescita selvaggia precedente. L'accento si sposta sul fattore umano e sulla necessità di una modernizzazione 'comprehensive, coordinated and sustainable'. Questo cambio di rotta è interpretato come una risposta a segnali di crescente instabilità interna, come la corruzione, l'inquinamento, le disuguaglianze sociali e l'aumento delle proteste popolari, evidenziate anche dal calo delle esportazioni (-12.4%) e dall'aumento dell'inflazione (+6.8%).
2. Contraddittorie Politiche Internazionali e la Questione dello Yuan
La Cina, nonostante la necessità di aggiustare la rotta interna, continuava a perseguire i propri interessi a livello internazionale, mostrando un'immagine contraddittoria. L'atteggiamento di Pechino durante i vertici del G20 tra il 2008 e il 2009 evidenzia questa ambiguità. Mentre la Cina cercava il riconoscimento formale del suo nuovo peso negli affari internazionali, rifiutava un condominio secondo le regole americane, considerando i sacrifici economici e socio-politici necessari insostenibili per la sua fragile stabilità interna. Tuttavia, l'offensiva cinese per ridefinire il sistema monetario internazionale appariva sempre più evidente. Il governatore della Bank of China propose la sostituzione del dollaro come valuta di riserva internazionale, un messaggio ribadito dal Consigliere di Stato Dai Binguo al G8 de L'Aquila e nella prima dichiarazione congiunta dei BRICS nel 2009. La Cina iniziò a concludere diversi Currency Swap Agreements basati sullo Yuan, dagli stati dell'ASEAN al Brasile, dalla Russia all'India. Questo, pur senza minacciare immediatamente l'egemonia del dollaro, poneva le basi per una futura regionalizzazione e internazionalizzazione del Renminbi. L'acquisto di diritti speciali di prelievo (SDR) del FMI per 43 miliardi di dollari nel 2009 dimostrava la volontà di Pechino di presentarsi come un membro responsabile della comunità internazionale e di aumentare il proprio peso istituzionale. Il paradosso, però, risiedeva nel fatto che la Cina era costretta ad acquistare massicciamente dollari e Treasury Bonds, con l'utilizzo dello Yuan nelle transazioni internazionali che rimaneva modestissimo (0.8%).
3. Crisi Interna e Tentativo di Calmare le Acque 2011 2012
Tra il 2011 e il 2012, di fronte a una complessa transizione interna, alle manovre americane di riposizionamento nell'area Asia-Pacifico e alle crescenti rimostranze dei paesi limitrofi, Pechino ha cercato di mitigare le tensioni e di presentare un'immagine di maggiore pacifismo. Questo approccio si è manifestato nell'accordo quadro del 2011 con l'ASEAN per implementare il Codice di Condotta, nella pressione sulla Corea del Nord per riavviare i negoziati sulla denuclearizzazione (culminati in un accordo intermedio nel 2012), nelle visite diplomatiche del Consigliere di Stato Dai Binguo in India e Vietnam (con una visita di reciprocità del primo ministro vietnamita a Pechino), nella visita del presidente Hu a Pechino con il presidente filippino Benigno Aquino e con il primo ministro giapponese Noda (con un accordo per l'utilizzo dello Yuan nelle transazioni bilaterali), e nella creazione del primo "China-South Korea Strategic Defence Dialogue". Sono stati anche avviati negoziati per la creazione di una zona di libero scambio con Corea del Sud e Giappone (il cui commercio trilaterale nel 2011 ammontava a 690 miliardi di dollari). La pubblicazione del Libro Bianco governativo sul Peaceful Development ribadisce questo impegno per la stabilità regionale. Nonostante questo sforzo diplomatico, l'ingerenza americana nell'internazionalizzazione delle dispute, contrastando con il metodo bilaterale preferito dalla Cina, è stata criticata dai media cinesi, che hanno accusato alcuni paesi occidentali di distorcere la questione del Mar Cinese Meridionale, provocando conflitti tra Cina e ASEAN. Nel frattempo, sono continuati gli scontri con la marina giapponese, vietnamita e filippina (2013-2014), confermando la complessità e le tensioni sottese alla politica cinese.
VI.La Nuova Assertività Cinese e il Progetto della Nuova Via della Seta 2013 2015
La nuova leadership cinese sotto Xi Jinping ha segnato un'intensificazione dell'assertività in politica estera. Il lancio della Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta) nel 2013 rappresenta un ambizioso progetto infrastrutturale per connettere la Cina all'Europa e ad altre regioni, aumentando l'influenza cinese a livello globale. Questo progetto, finanziato da un fondo iniziale di 40 miliardi di dollari (e successivi investimenti), assieme alla fondazione della AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), riflette la volontà di Pechino di rimodellare l'architettura economica globale, sfidando il ruolo del dollaro come valuta di riserva.
1. L ascesa di Xi Jinping e una nuova assertività cinese
L'ascesa di Xi Jinping alla guida della Cina nel 2013 ha segnato una svolta nella politica estera del paese, caratterizzata da una maggiore assertività. Il documento evidenzia questa nuova fase, contrapponendola alla politica più cauta dei precedenti leader. Questo aumento di assertività si manifesta sia nella politica interna, con la lotta alla corruzione e la creazione di nuovi gruppi di potere come la National Security Commission, sia nella politica estera, con un approccio più deciso nelle dispute territoriali e una maggiore attenzione alla diplomazia periferica. L'obiettivo dichiarato è quello di instaurare rapporti di potenza paritetici con gli Stati Uniti, rivendicando un ruolo più importante nel sistema internazionale. La CPC Foreign Affairs Working Conference di novembre, durante la quale Xi Jinping ha presentato le direttive della nuova politica estera, conferma questa direzione. Mentre si riconosce una tendenza alla multipolarizzazione e alla globalizzazione, si sottolinea anche la mancanza di una reale riforma democratica del sistema internazionale. Questo porta la Cina a perseguire una diplomazia più indipendente e assertiva, focalizzata su tre punti principali: la relazione con gli Stati Uniti, i rapporti con i paesi della sua periferia e la protezione dei propri interessi nazionali fondamentali ('core interests').
2. La Nuova Via della Seta Un progetto infrastrutturale di portata globale
Il lancio della Belt and Road Initiative (BRI), nota anche come Nuova Via della Seta, nel settembre 2013, rappresenta un elemento chiave di questa nuova assertività cinese. L'iniziativa, presentata da Xi Jinping durante una visita in Asia centrale, è descritta come un progetto ambizioso per creare una nuova rete infrastrutturale che colleghi la Cina all'Europa e ad altre regioni. Xi Jinping, evocando le immagini della vecchia Via della Seta, ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale e di un rafforzamento della collaborazione politico-strategica. Il progetto, che prevede la costruzione di infrastrutture sia terrestri (attraverso le repubbliche centroasiatiche, Iran, Turchia, Mosca e Duisburg) che marittime (passando dall'India all'Africa, attraverso il canale di Suez ad Atene e Venezia, fino alla Germania), è finanziato da un cospicuo investimento iniziale di 40 miliardi di dollari (con ulteriori investimenti previsti). L'iniziativa si avvale anche del ruolo della neonata AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) e di progetti aggiuntivi come la creazione di un nuovo canale di Panama in Nicaragua e un canale nell'istmo di Kra in Tailandia per bypassare lo stretto di Malacca. La concessione di 35 anni alla COSCO per il porto di Atene e la visita di Li Keqiang a Belgrado nel 2014 per un meeting con 16 paesi dell'Europa centro-meridionale, focalizzato sulla costruzione di infrastrutture che colleghino il Pireo all'Europa occidentale, dimostrano l'ambizione e la portata di questo progetto, che rappresenta una sfida all'influenza americana e una nuova fase nell'espansione dell'influenza economica e geopolitica cinese.
3. La sfida all egemonia del dollaro e il ruolo dell AIIB
La Nuova Via della Seta si inserisce in un quadro più ampio di sfida all'egemonia americana, in particolare all'egemonia del dollaro. Il documento cita un articolo del Wall Street Journal che evidenzia come la Cina, pur promuovendo l'inclusione dello Yuan negli SDR del FMI, abbia evitato di aumentare il proprio peso nel consiglio direttivo dell'istituzione. Questa scelta è interpretata come una strategia per mantenere le distanze dagli istituti occidentali e per negoziare una maggiore influenza, come poi avvenuto con la partecipazione ai vertici dell'AIIB. L'agenzia di stampa Xinhua ha ribadito che la Cina, pur essendo l'iniziatrice dell'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), non cerca un ruolo dominante, ma vuole condividere i frutti del suo sviluppo e costruire una comunità di destino comune attraverso la cooperazione internazionale e regionale. La Cina critica il sistema economico globale esistente, dominato dai paesi occidentali, come non rappresentativo dell'architettura economica mondiale. L'AIIB è concepita in stretto collegamento con la dottrina della "March Westward" e con altre iniziative come la nuova banca dei BRICS, la proposta di una propria Free Trade Area of Asia Pacific e l'implementazione del China International Payment System (CIPS), che permetterà di effettuare transazioni internazionali in RMB senza dipendere da centri off-shore o banche cinesi. Queste azioni rappresentano un chiaro tentativo di creare un'alternativa al sistema finanziario e commerciale dominato dagli Stati Uniti.
VII.La Strategia dello Smart Power Americano e la Reazione Cinese alle Primavere Arabi
La risposta americana alle Primavere Arabe si è caratterizzata per l'ambiguità e per l'adozione di uno smart power, che ha combinato soft power e interventi mirati, evitando ingaggi militari diretti. La Cina, invece, ha risposto con cautela e pragmatismo, priorizzando la stabilità regionale e proteggendo i suoi interessi economici nella macroregione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), che rappresentava una fonte cruciale di energia per la Cina (circa il 60% del suo fabbisogno).
1. Lo Smart Power americano e le sue implicazioni
La risposta americana alle Primavere Arabi è analizzata attraverso il paradigma dello 'smart power', una combinazione di hard e soft power. Questo approccio, in linea con l'obiettivo di mantenere la leadership globale americana, prevedeva un impegno strategico selettivo, investendo tempo ed energie laddove più opportuno per sostenere la leadership americana a lungo termine. Il testo evidenzia però il potenziale effetto destabilizzante di questa strategia sull'ordine internazionale. La rinuncia a interventi militari diretti o preventivi, a favore di strumenti come il soft power, gli attacchi finanziario-monetari, le sanzioni economiche, gli interventi cibernetici e le operazioni paramilitari off-the-records, presuppone l'accettazione di una certa instabilità sistemica. Questa logica, riconducibile al principio del 'divide et impera', mirava a creare una competizione tra potenze regionali, distogliendole dalla competizione globale con gli Stati Uniti. Tuttavia, la strategia del caos, più che indebolire la Cina, avrebbe potuto minare le fondamenta del sistema internazionale, privato sia della stabilità dell'era bipolare che di un arbitro ultimo come gli Stati Uniti dopo la Guerra Fredda. La potenziale instabilità prodotta dalla strategia americana è ulteriormente analizzata considerando la sua applicazione in diverse regioni, dal Sahel all'Asia Centrale, evidenziando i possibili esiti sistemici difficilmente controllabili.
2. La Cautela Cinese e gli Interessi nel MENA
La Cina, a differenza degli Stati Uniti, ha reagito alle Primavere Arabi con una combinazione di minimalismo e pragmatismo, che caratterizza la sua politica estera. Il documento evidenzia come la RPC avesse interessi tangibili e diretti nella macroregione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), sia di natura economico-energetica che politica. La necessità di impedire l'instaurazione di un ordine regionale sfavorevole ai legami con Pechino ha portato la Cina ad adottare una risposta improntata alla cautela e alla massima flessibilità. La risposta cinese, tra le ultime a essere rese pubbliche, è arrivata a metà febbraio 2011, dopo un attento monitoraggio dei flussi informativi online. Il portavoce del Ministero degli Esteri Ma Zhaoxu ha sottolineato l'urgenza di ristabilire l'ordine senza interferenze esterne. Questo approccio, in linea con i capisaldi della politica estera cinese (tutela della stabilità interna ed internazionale, non-ingerenza negli affari interni degli Stati, sviluppo economico), lascia trasparire il disagio di Pechino di fronte agli eventi. Le preoccupazioni dei vertici del PCC erano molteplici: l'instabilità regionale minacciava gli interessi economici e energetici della Cina nella zona MENA; la situazione socio-economica nei paesi arabi, pur diversa da quella cinese, poteva comunque generare un effetto contagio; e la necessità di mantenere rapporti stabili con tutti i paesi della regione per impedire la formazione di un fronte ostile a Pechino.
3. Gli Interessi Economici e Energetici Cinesi nel MENA
L'importanza della regione MENA per lo sviluppo economico cinese è sottolineata dall'elevato volume del commercio bilaterale, che nel 2011 superava i 300 miliardi di dollari, superando di gran lunga quello americano (193 miliardi). Questa situazione spiega l'impegno di Pechino nel dialogo con tutti i paesi della regione, come dimostrato dalla creazione di una missione speciale e dalle numerose missioni diplomatiche di Xi Jinping e Wen Jiabao in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Turchia (2011-2012), e dalla ricezione di delegati da Iraq, Sudan, Turchia e Afghanistan. Sul versante energetico, il sorpasso della Cina sugli USA come primo consumatore di energia mondiale nel 2013, e la previsione dell'IEA che il 30% della crescita della domanda globale di energia entro il 2023 dipenderà dalla Cina, evidenziano la dipendenza di Pechino dall'approvvigionamento estero. Il Medio Oriente fornisce circa il 60% dell'energia consumata dalla Cina, rendendo l'instabilità regionale una seria preoccupazione geoeconomica. Questa instabilità si traduceva in aumenti dei costi di importazione di idrocarburi, in un contesto di inflazione moderata, riduzione delle esportazioni e minori surplus di partite correnti, mettendo in luce le conseguenze economiche dell'instabilità per la Cina.
VIII.La Nuova Guerra Fredda Ucraina e il Rapporto Sino Russo
L'intervento americano in Ucraina, volto a contrastare l'influenza russa, ha avuto l'effetto inaspettato di rafforzare il rapporto sino-russo, accelerando il processo di multipolarizzazione del sistema internazionale. La Cina ha sfruttato le tensioni tra USA e Russia per consolidare i suoi legami con Mosca, ampliando ulteriormente la sua influenza geopolitica.
1. L intervento in Ucraina e la percezione di una nuova guerra fredda
La sezione analizza l'impatto dell'intervento americano in Ucraina (a partire dal 2014) sulle relazioni internazionali, in particolare sul rapporto tra Stati Uniti, Russia e Cina. L'evento è visto come un fattore chiave nell'aggravamento delle tensioni tra Stati Uniti e Russia, portando alcuni analisti a parlare di una 'nuova guerra fredda'. Il coinvolgimento americano in Ucraina è interpretato come un tentativo di indebolire la Russia, contrastando le sue azioni in Medio Oriente (caso Snowden) e impedendo un rafforzamento dell'asse Berlino-Mosca. L'accordo di partenariato tra Ucraina e Unione Europea, considerato come una mossa per sottrarre Kiev all'influenza russa, è presentato come un elemento chiave di questa strategia. Questo accordo, che riguarda una zona di confine cruciale tra Russia ed Europa, non solo limita l'accesso russo alle pipeline energetiche, ma interessa anche la Crimea, territorio annesso dalla Russia nel 2014. L'intervento americano nell'Euromaydan e il sostegno (anche indiretto) ai movimenti anti-Janukovich, insieme all'azione militare russa in Crimea, sono descritti come elementi di un conflitto più ampio che ha destabilizzato la regione.
2. Le conseguenze inattese il rafforzamento del rapporto sino russo
L'intervento americano in Ucraina, pur mirato a indebolire la Russia, ha avuto l'effetto inatteso di rafforzare il rapporto tra Russia e Cina. Questo avvicinamento tra Mosca e Pechino è considerato una conseguenza diretta dell'azione americana. Secondo il documento, la strategia di 'caos controllato' degli Stati Uniti, che consiste nel fomentare e cavalcare crisi globali, affidandone la gestione ad altri attori, ha portato la Russia, in un contesto di crisi politica ed economica, a stringere un legame più stretto con la Cina. Questo avvicinamento tra Russia e Cina, che ha radici storiche (a partire dal 1989, con il consolidamento dei legami tramite l'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione - SCO - e gli accordi sui confini disputati), si è rafforzato ulteriormente in ambito commerciale ed energetico (accordi sulle forniture energetiche del 2010 con Rosfnet e Transfnet, intensificazione della cooperazione durante la visita di Xi nel 2013). La convergenza di interessi tra Mosca e Pechino su questioni mediorientali e l'apertura sulla questione siberiana sono elementi chiave di questo rafforzamento del legame tra le due potenze. Si ipotizza che, a lungo termine, questa strategia americana possa portare all'espulsione degli Stati Uniti dall'Eurasia, con la Cina come principale beneficiario di questo riassetto geopolitico ('In Ukraine the winner is..China').
3. Il dialogo Obama Xi e le proteste di Hong Kong
Nonostante la crescente tensione, il dialogo bilaterale tra Obama e Xi Jinping è continuato, come dimostrato dall'incontro al vertice APEC di fine 2014. Questo incontro, che si è svolto in concomitanza con le proteste popolari di Hong Kong, è interpretato come una prova della nuova posizione di forza della Cina e della necessità di gestire le pressioni americane. La Cina, pur mostrando risolutezza e censura nei media nazionali sulla gestione delle proteste di Hong Kong, ha lasciato che il movimento scemasse autonomamente, memorizzando le conseguenze internazionali degli eventi di Tienanmen. Il governo cinese ha accusato gli Stati Uniti di essere coinvolti nelle proteste, citando il coinvolgimento di "external forces". La pubblicazione di un White Paper che sottolineava che l'autonomia di Hong Kong derivasse dall'autorizzazione della leadership centrale cinese è vista come un'azione preventiva. L'incontro Obama-Xi, dopo la sconfitta di Obama alle elezioni di midterm, è considerato un'ulteriore prova della nuova posizione di forza cinese e della necessità di mitigare le pressioni americane. Si evidenzia, come punto di accordo, l'impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra e la creazione di un meccanismo di comunicazione in caso di contatto tra le forze armate, mentre la Cina continuava a promuovere la Nuova Via della Seta e il progetto FTAAP/RCEP, come sfida al progetto americano del TPP.
IX.La Battaglia Aeronavale del Pentagono Air Sea Battle ASB e Anti Access Area Denial A2 AD
La percezione di una crescente minaccia cinese, in particolare la sua strategia A2/AD, ha spinto il Pentagono a sviluppare la dottrina Air-Sea Battle (ASB), volta a mantenere la supremazia militare americana nei global commons. Tuttavia, questa strategia ha suscitato critiche per i suoi alti costi, i rischi di escalation e la mancanza di una chiara strategia di vittoria. Alternative, come il distant blockade, sono state proposte per contrastare la Cina a costi inferiori.
1. La percezione della minaccia cinese e le origini dell Air Sea Battle ASB
La percezione della Cina come potenziale minaccia allo status quo americano è un tema ricorrente nel dibattito politico statunitense. Il documento evidenzia come questa percezione, sebbene influenzata da difficoltà di intelligence riguardo alle capacità militari cinesi (come dimostrato dall'incidente dell'EP-3 nel 2001), sia alla base della pianificazione strategica del Pentagono. La difficoltà di raccogliere informazioni accurate sulle capacità militari cinesi, accentuate dall'eccessiva fiducia americana nelle informazioni ottenute dall'acquisto di armi e tecnologia dalla Russia, non ha impedito la progressiva presa di coscienza della minaccia rappresentata dalle capacità cinesi di Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Già dal 1997, nel Defense Panel Report, si fa riferimento a queste tecniche, poi riprese nel QDR del 2001. La National Security Strategy del 2006 sottolinea esplicitamente il potenziale della Cina per competere militarmente con gli Stati Uniti, evidenziando la necessità di misure per prevenire l'egemonia cinese nell'Asia-Pacifico o a livello globale. Il concetto operativo dell'ASB, ufficialmente introdotto nel 2010, ha radici nel periodo post-Guerra Fredda, quando la minaccia sovietica è stata progressivamente sostituita da quella cinese, almeno fino all'11 settembre 2001. Il ruolo dell'Office of Net Assessment (ONA) del Pentagono, guidato da Andrew Marshall, è stato fondamentale nell'identificare precocemente le intenzioni egemoniche della Cina e nel promuovere lo sviluppo di nuove strategie militari.
2. L Air Sea Battle ASB come risposta alla strategia A2 AD cinese
Il concetto di Air-Sea Battle (ASB), sebbene non esplicitamente indirizzato a un avversario specifico, è stato sviluppato come risposta alla strategia A2/AD cinese. Il documento evidenzia come l'ASB sia stata in fase di elaborazione già dal periodo post-Guerra Fredda, con una maggiore accelerazione dopo gli attentati dell'11 settembre. L'obiettivo dell'ASB, secondo gli strateghi americani, è quello di mantenere la supremazia militare americana nei 'global commons' (cieli, mari, terra, spazio e cyberspazio) e di preservare il gap tecnologico americano come strumento di egemonia. La Defense Strategic Guidance del gennaio 2012 conferma questo obiettivo, sottolineando la necessità di mantenere capacità militari rilevanti e interoperabili per assicurare l'accesso e l'uso dei 'global commons'. Andrew Krepinevich, collaboratore di Andrew Marshall, ha identificato nell'A2/AD cinese la più grave minaccia alla capacità di proiezione di potenza degli Stati Uniti. L'ASB, secondo Krepinevich, rappresenta una scelta strategica di primaria importanza per gli Stati Uniti: o si accetta l'avanzata di un nuovo ordine mondiale o si investe in nuove strategie come l'ASB e nello sviluppo di partnership strategiche con attori regionali.
3. Critiche all ASB e alternative strategiche
Il concetto di ASB ha ricevuto diverse critiche, provenienti da diverse figure, tra cui strateghi militari e analisti. Le critiche evidenziate nel documento mettono in discussione l'efficacia e la fattibilità dell'ASB. Alcuni lo considerano una giustificazione per l'aumento delle spese militari in settori di interesse per le lobby congressuali, definendolo una 'Self-Serving Fantasy' del Military-Industrial Complex. Figure autorevoli, come Thomas Barnett e il Generale Cartwright, mettono in dubbio la natura stessa dell'ASB, considerandola né una dottrina né uno scenario concreto. Altri analisti, come Thomas Hammes, sottolineano che l'ASB potrebbe essere efficace in alcuni contesti, ma non contro la Cina. Ulteriori critiche riguardano il costo proibitivo della costruzione di una flotta aeronavale basata sull'ASB, il rischio di una distruzione umana ed economica incalcolabile in caso di conflitto con la Cina e la mancanza di una chiara strategia di vittoria o di 'exit strategy'. Un'alternativa proposta al modello ASB è il 'distant blockade', un blocco navale a distanza che sfrutti la geografia e i punti di forza delle forze armate statunitensi per impedire alla Cina l'accesso ai choke points fondamentali, creando una 'maritime no-man’s-land' senza il rischio di una escalation nucleare. Questa strategia, pur presentando vantaggi in termini di costo e rischio, presenta difficoltà logistiche e diplomatiche.
X.La Strategia Cinese Pragmatismo Soft Power e la Sfida all Egemonia Americana
La Cina ha adottato una strategia pragmatica, combinando crescita economica, soft power, e una politica estera abilmente dissimulata. Imparando dalla storia e dalla realpolitik, Pechino ha sfruttato le opportunità create dalle debolezze della politica estera americana per ampliare la sua influenza globale, sfidando l'egemonia del dollaro e cercando di costruire un ordine internazionale più multipolare. Questo ha portato a una nuova percezione di sé stessa come potenza in grado di contrastare la supremazia americana, almeno regionalmente.
1. La percezione della minaccia e la difficoltà di intelligence
Il capitolo inizia evidenziando la percezione, nel dibattito politico americano, della Cina come attore in grado di alterare lo status quo, tema ricorrente nell'era unipolare. La difficoltà nell'acquisire informazioni certe sugli sviluppi dottrinali e sull'ammodernamento militare cinese è un ostacolo significativo. Questo è dovuto, in primo luogo, alle difficoltà nel condurre operazioni di spionaggio in Cina, come dimostrato dall'incidente dell'EP-3 nel 2001 e dal conseguente stallo diplomatico. Il Comandante del PACOM (United States Pacific Command) nel 2009, Robert Willard, ha ammesso che la Cina ha superato molte stime di intelligence sulle sue capacità militari. La fiducia eccessiva di Washington nell'acquisto di armi e tecnologia dalla Russia, sminuendo le capacità cinesi di innovazione e spionaggio, ha contribuito a questa mancanza di chiarezza. Tuttavia, già dal 1997, nel Defense Panel Report, si evidenziava l'uso da parte della Cina di tecniche Anti-Access/Area Denial (A2/AD), tema ripreso nel QDR del 2001, che sottolineava l'emergere di un competitor asiatico con risorse formidabili. L'allora segretario alla difesa Rumsfeld, fautore di una rivoluzione tecnologica militare, aveva avviato una collaborazione con i think tank del Pentagono per lo sviluppo di scenari e dottrine strategiche a lungo termine, iniziata sotto la presidenza Ford.
2. L Air Sea Battle ASB come risposta strategica
A partire dalla National Security Strategy del 2006, la Cina viene indicata come la principale potenza con il potenziale per competere militarmente con gli Stati Uniti, necessitando di misure per prevenire la sua egemonia. L'Air-Sea Battle (ASB), ufficialmente introdotta nel 2010, è presentata come una risposta a questa crescente minaccia, sebbene formalmente non mirata a un avversario specifico. Il suo sviluppo risale al periodo post-Guerra Fredda, quando la minaccia sovietica è stata progressivamente sostituita da quella cinese, fino agli eventi dell'11 settembre. L'Office of Net Assessment (ONA) del Pentagono, diretto da Andrew Marshall, ha giocato un ruolo chiave nell'identificare precocemente la minaccia rappresentata dalle capacità militari cinesi, soprattutto nel settore A2/AD. Andrew Krepinevich, collaboratore di Marshall, ha enfatizzato il pericolo rappresentato dall'A2/AD cinese per la proiezione di potenza americana, portando alla necessità di una nuova strategia. L'ASB è definita come lo strumento per mantenere una 'full spectrum dominance' nei 'global commons', ovvero il controllo di cieli, mari, terra, spazio e cyberspazio. Un rapporto del CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments) del 2014, "Toward a New Offset Strategy", conferma l'erosione della capacità di proiezione di potenza americana e la necessità di una nuova strategia per ripristinarla.
3. Critiche all ASB e alternative il Distant Blockade
Il documento presenta le critiche all'ASB, provenienti da diverse fonti, che ne mettono in dubbio l'efficacia e la fattibilità. Secondo alcuni, l'ASB è una giustificazione per l'aumento delle spese militari a favore di alcune lobby, una 'Self-Serving Fantasy' secondo Thomas Barnett. Il Generale Cartwright, ex vice-chairman del Joint Chiefs of Staff, la definisce né una dottrina né uno scenario. Analisti come Thomas Hammes mettono in discussione l'applicabilità dell'ASB alla situazione specifica con la Cina. Criticano anche l'elevato costo e l'assenza di una 'theory of victory' o 'exit strategy'. Un rapporto interno del comando dei Marines, pubblicato dal Washington Post, avverte dei rischi di una distruzione umana ed economica incalcolabile in caso di conflitto con la Cina. Come alternativa, viene proposto il 'distant blockade', una strategia che, a differenza dell'ASB, evita l'attacco diretto al territorio cinese e si concentra sulla pressione economica e militare tramite il blocco dei choke points fondamentali (stretti di Malacca, Lombok e Sunda). Douglas Peifer definisce questa strategia 'viable' e a basso costo, ma si evidenziano le difficoltà logistiche e diplomatiche, incluso il bisogno di alleati disposti a sostenere gli oneri e le variabili legate al controllo della domanda energetica cinese e all'elasticità dei prezzi.
Riferimento del documento
- Remarks on Tienanmen Square Incidents, 1989
- President Bush and Premier Wen Jiabao Remarks to the Press, 9/12/2003
- Presidential Address to the Federal Assembly, 4/12/2014
