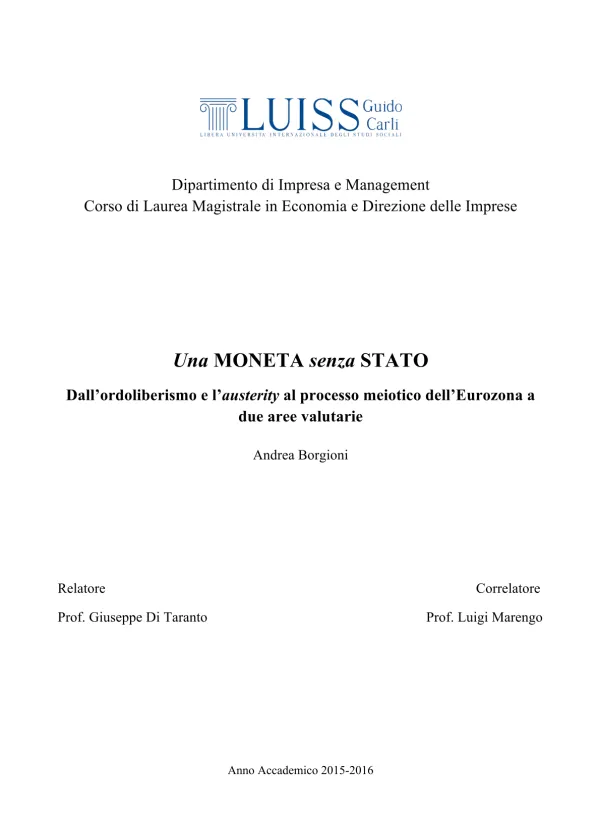
Eurozona: Due Monete?
Informazioni sul documento
| Scuola | Dipartimento di Impresa e Management, Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese |
| Specialità | Economia e Direzione delle Imprese |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea Magistrale |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 11.55 MB |
Riassunto
I.L Eurozona come Area Valutaria Non Ottimale Un Analisi Comparativa con l Ipotesi di un Europa a Due Monete
Questo documento analizza criticamente l'Eurozona, sostenendo che non rappresenta un'area valutaria ottimale (OCA) a causa dell'imposizione del modello ordoliberale tedesco. L'analisi confronta l'unificazione monetaria tedesca con quella europea, evidenziando come la rivalutazione forzata delle monete nei paesi meno competitivi (come la RDT e il Sud Europa) e le privatizzazioni spesso fallimentari abbiano contribuito alla crisi attuale. Il documento propone l'ipotesi di un'Europa a due aree monetarie o, più radicalmente, un'uscita dall'euro per i paesi più indebitati come strategia per sfuggire alla trappola dell'austerità e recuperare la sovranità monetaria. L'analisi si concentra sui parametri del Trattato di Maastricht e del Fiscal Compact, mostrando come abbiano limitato la sovranità degli stati, soprattutto quelli del Sud Europa, a vantaggio della Germania.
II.L Ordoliberismo Tedesco e l Unione Monetaria Europea
Il documento approfondisce il ruolo dell'ordoliberismo nell'Unione Monetaria Europea (UME), mettendo in luce la sua influenza sulla politica economica europea e la sua connessione con il modello tedesco. Viene analizzato il ruolo della Bundesbank e la critica di personaggi come Karl-Otto Pohl e Rudiger Pol all'unificazione monetaria tedesca. Si evidenzia come il principio della stabilità dei prezzi, promosso dalla Banca Centrale Europea (BCE), e l'austerità fiscale abbiano generato un differenzialismo finanziario a favore dei paesi del Nord, in particolare la Germania, a discapito dei paesi del Sud. L'adozione del modello ordoliberale ha comportato una progressiva perdita di sovranità degli stati, tramite l'introduzione di trattati sempre più vincolanti, quali il Fiscal Compact e i parametri di Maastricht.
1. L ordoliberismo tedesco principi e applicazione nell Unione Monetaria Europea
Questa sezione approfondisce il modello economico ordoliberale tedesco e la sua influenza sull'Unione Monetaria Europea. L'analisi parte dall'esame dei principi fondamentali dell'ordoliberismo, evidenziando il ruolo centrale della stabilità dei prezzi, l'autonomia della banca centrale, la promozione della concorrenza e il minimo intervento statale nell'economia. Si evidenzia come questi principi, radicati nell'esperienza tedesca, siano stati applicati, con diverse modalità, anche all'interno dell'Unione Monetaria Europea, con conseguenze spesso criticate. Il documento sottolinea il differenzialismo finanziario creato all'interno dell'Eurozona, con una gerarchia istituzionale che vede l'ordinamento dell'UE prevalere su quelli nazionali, e un progressivo trasferimento di competenze dai governi nazionali agli organi dell'Unione Europea. Questo processo, attuato tramite una proliferazione di trattati (parametri di Maastricht e Fiscal Compact), ha limitato la sovranità statale in materia di politica economica e finanziaria, generando un divario sempre più ampio tra i paesi del Nord e quelli del Sud Europa.
2. Critiche all ordoliberismo e il suo impatto sull Eurozona
La sezione prosegue analizzando le critiche al modello ordoliberale e al suo impatto sull'Eurozona. Vengono menzionate le voci contrarie al progetto di unione monetaria, sia in Germania (Karl-Otto Pohl, presidente della Bundesbank) che nella RDT (Rudiger Pol), che evidenziavano i potenziali problemi per le imprese dell'Est a fronteggiare la concorrenza internazionale e la riduzione della domanda interna. Il documento sottolinea come l'applicazione del modello ordoliberale abbia portato a una perdita di sovranità monetaria e a una limitata autonomia della politica fiscale per i paesi più deboli, favorendo la Germania. Si evidenzia la demonizzazione del credito di ultima istanza, anche se recentemente rivalutato, come ulteriore ostacolo alla crescita economica dei paesi in difficoltà. La critica si estende anche all'imposizione di politiche di austerità, considerate recessive dal FMI, con un impatto negativo sulla crescita economica e sul welfare state dei paesi del Sud Europa. Il ruolo della BCE, inizialmente focalizzata sulla stabilità dei prezzi e non sul ruolo di prestatore di ultima istanza, è analizzato come elemento chiave del sistema ordoliberale.
3. Il modello ordoliberale in Europa una sintesi e la sua contrapposizione ai valori democratici
Questa parte offre una sintesi del modello ordoliberale promosso dalla Germania in Europa, evidenziando la sua gerarchizzazione finanziaria e istituzionale, con la prevalenza dell'ordinamento UE su quelli nazionali. Viene sottolineato l'impatto negativo sulle economie più deboli, a causa dei parametri di Maastricht, del Fiscal Compact e della devoluzione della politica monetaria alla BCE. Il documento mette in luce l'incompatibilità tra il modello ordoliberale e i valori democratici insiti nelle costituzioni degli stati europei, evidenziando come l'integrazione monetaria non abbia saputo conciliare la sovranità condivisa con le esigenze e i diritti fondamentali dei popoli europei. Le conseguenze sociali negative del modello ordoliberale, con la sua enfasi sull'austerità e la limitazione della sovranità statale, sono presentate come elementi di contrasto con un'idea di Europa più equa e solidale. L'opinione di Alberto Bagnai, che considera l'introduzione dell'euro come un'imposizione di un'élite a un popolo ignaro, e la sua critica al Trattato di Maastricht e al cambio fisso sono riportate per rafforzare la critica al modello in esame.
III.Le Politiche di Austerità e le Loro Conseguenze
Si critica la politica di austerità imposta all'Eurozona, confutando la teoria dell'austerità espansiva con dati del FMI, che mostrano come l'austerità abbia effetti recessivi. Il documento cita gli errori metodologici nello studio di Reinhart e Rogoff sull'argomento e si riferisce alle teorie di economisti come Hyman Minsky e Paul Krugman. Viene evidenziato il costo sociale delle riforme strutturali imposte ai paesi del Sud Europa, con la perdita di sovranità monetaria e di autonomia nella politica fiscale. L'analisi si focalizza anche sul 'Ciclo dell'annessione espansiva', descrivendo la strategia tedesca di consolidamento del proprio potere economico nell'Eurozona.
1. Critiche alle politiche di austerità e l impatto sull economia
Questa sezione si concentra sulle critiche alle politiche di austerità imposte nell'Eurozona, evidenziando le loro conseguenze negative sull'economia. Il documento confuta la teoria dell'austerità espansiva, citando studi del FMI che dimostrano come i consolidamenti fiscali abbiano tipicamente effetti recessivi nel breve termine, riducendo l'output e aumentando la disoccupazione. Vengono evidenziati gli errori metodologici nello studio di Reinhart e Rogoff, che sostenevano una correlazione tra alto debito pubblico e bassa crescita economica, errori che sono stati contestati da diversi economisti, tra cui Paul Krugman. La critica all'austerità si basa anche sulle teorie di economisti come Hyman Minsky, che evidenzia l'instabilità intrinseca del sistema capitalistico legata alle variabili finanziarie, e di Keynes, la cui idea che il boom, e non la recessione, sia il momento opportuno per l'austerità, viene citata a sostegno delle critiche. L'analisi evidenzia che le politiche di austerità, anziché aiutare i paesi in crisi, hanno aumentato il divario tra gli Stati, favorendo la Germania e penalizzando i paesi del Sud Europa.
2. L esperienza italiana e le riforme strutturali
La sezione analizza l'impatto delle politiche di austerità sull'economia italiana dopo l'ingresso nell'Eurozona. L'adesione all'euro ha comportato la perdita di strumenti cruciali per la gestione dell'economia, come la svalutazione della lira, e ha spinto verso riforme strutturali considerate fallimentari a causa degli elevati costi sociali. Queste riforme, caratterizzate da un ridimensionamento dei diritti sociali e del lavoro, hanno portato a una riduzione delle tutele per i lavoratori, con un conseguente deprezzamento del valore del lavoro. L'analisi cita economisti come Giuseppe Travaglini, che sostiene che il basso costo del lavoro ha disincentivato le imprese ad accrescere l'efficienza, favorendo attività a basso valore aggiunto. Si conclude che le riforme hanno avuto un impatto negativo sull'investimento di qualità, sui processi innovativi e sulla crescita della ricchezza nazionale. La perdita di sovranità monetaria e l'autonomia limitata della politica fiscale sono presentate come il prezzo pagato dall'Italia, a vantaggio della Germania e dei paesi del Nord Europa.
3. Confronti internazionali e prospettive di crescita
Il paragrafo presenta dati a confronto internazionale per evidenziare le conseguenze delle politiche di austerità. L'OECD stima una crescita del PIL inferiore per l'Eurozona (+1,2%) rispetto agli USA (+2,6%), al Giappone (2,1%) e ai BRICS (+5,3%). I dati Eurostat del 2014 mostrano una crescita positiva del PIL solo per la Germania (+0,8%), mentre l'Olanda registra un dato negativo (-1,4%). I paesi del Sud Europa (Portogallo, Grecia, Cipro, Italia e Spagna) mostrano tassi di crescita al di sotto dello zero. L'analisi cita studi di Robert Gordon e Ian Dew-Backer, che evidenziano come nel breve periodo imposte più basse e deregolamentazione del mercato del lavoro aumentino l'occupazione ma deprimano la produttività, annullando i benefici di una maggiore occupazione. Questi dati supportano l'argomento principale del capitolo, ovvero che le politiche di austerità hanno effetti negativi a lungo termine sulla crescita economica e sul benessere sociale.
IV.Una Nuova Europa L Ipotesi di Due Aree Valutarie
La sezione finale del documento presenta l'ipotesi di un'Eurozona suddivisa in due aree valutarie, come soluzione di compromesso. Questa soluzione, considerata di 'second best', rappresenta un punto di partenza per costruire un'Europa più equa e solidale. L'analisi considera variabili cruciali per definire un'area valutaria ottimale, come la mobilità dei fattori produttivi, il grado di apertura al commercio internazionale e la convergenza dei tassi di inflazione. Il contributo di economisti come Ronald McKinnon e Peter Kenen è citato per supportare l'analisi. Si conclude sottolineando l'importanza di conciliare i valori democratici con le esigenze di una moneta unica.
1. L ipotesi di una nuova Europa a due aree valutarie una soluzione di compromesso
Questa sezione introduce l'ipotesi di una riorganizzazione dell'Eurozona in due aree valutarie distinte, presentata come una soluzione di compromesso (second best) rispetto alla situazione attuale. L'obiettivo è superare gli squilibri generati dall'applicazione del modello ordoliberale e creare un'Europa più equa e solidale. La proposta di un sistema a due aree monetarie non è considerata una soluzione definitiva, ma un punto di partenza per ridisegnare il sistema monetario europeo, offrendo un'alternativa alla situazione di stallo attuale e alla politica di austerità imposta dai paesi del Nord a quelli del Sud. L'idea è quella di permettere ai paesi in maggiore difficoltà economica di riacquistare parte della sovranità monetaria perduta, ottenendo strumenti di politica economica come la svalutazione della moneta e il finanziamento in deficit, al fine di stimolare la crescita economica e di ridurre gli squilibri esistenti tra i paesi membri.
2. Variabili chiave per la definizione di aree valutarie ottimali
Per valutare la fattibilità e l'efficacia dell'ipotesi di un'Europa a due aree valutarie, il documento delinea un percorso metodologico basato sull'analisi di variabili cruciali per la definizione di aree valutarie ottimali (OCA). Si prevede una review della letteratura economica sull'argomento, al fine di identificare un set di variabili che permettano di misurare il livello di ottimalità di un'area valutaria. Tra queste variabili, vengono menzionate: la mobilità dei fattori produttivi (in particolare, la mobilità del lavoro), il grado di apertura al commercio internazionale, il grado di diversificazione produttiva e la convergenza dei tassi di inflazione. Queste variabili, opportunamente analizzate e contestualizzate, contribuiranno a costruire un modello di misurazione che permetterà di valutare se e come un sistema a due aree valutarie possa rappresentare una soluzione migliore rispetto all'attuale struttura dell'Eurozona. L'analisi si avvale dei contributi di diversi economisti, tra cui Ronald McKinnon e Peter Kenen, le cui teorie saranno integrate nel modello di misurazione.
3. Contributo di economisti e conclusioni preliminari
La sezione finale riporta il contributo di diversi economisti al dibattito sulle aree valutarie ottimali. Ronald McKinnon, noto per i suoi studi sull'economia internazionale e sullo sviluppo economico, è citato per la sua posizione favorevole alla stabilità del cambio in un'economia aperta, sostenendo che la variabilità dei cambi incide poco sull'equilibrio della bilancia dei pagamenti, compensata dagli effetti sui prezzi interni. McKinnon propone quindi un regime di cambi fissi e interventi sulle componenti di spesa interna per migliorare il saldo commerciale e controllare l'inflazione. Peter Kenen, invece, evidenzia come in un'economia fortemente diversificata, i cali della domanda in alcuni settori possano essere compensati da aumenti in altri, favorendo la mobilità del lavoro. Tuttavia, il modello di Kenen è applicabile solo in condizioni specifiche, come l'offerta di lavoro infinitamente elastica e la variazione del prezzo sul mercato internazionale proporzionale alla variazione del salario. In sintesi, questa sezione pone le basi per un'analisi empirica più approfondita, che utilizzerà i dati raccolti e le teorie presentate per valutare la fattibilità e l'efficacia della proposta di un'Europa a due aree valutarie.
